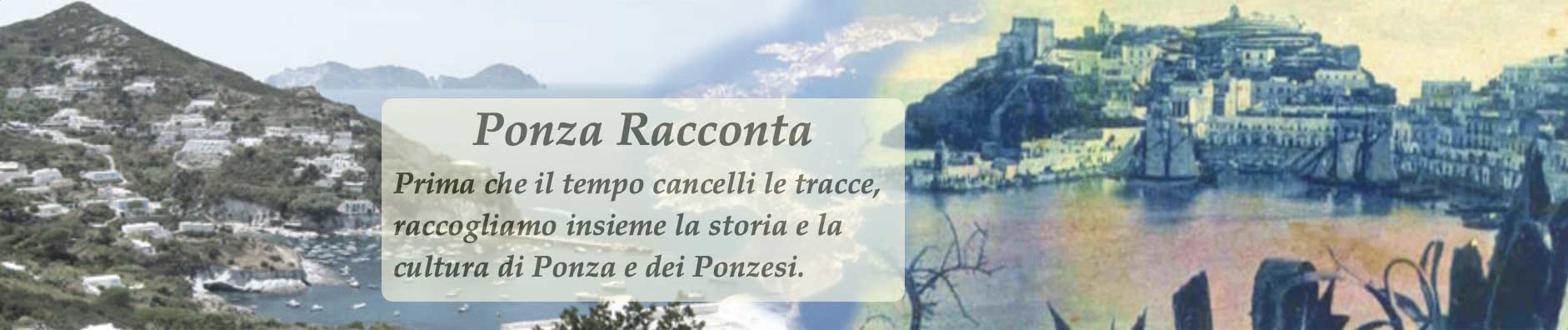di Pasquale Scarpati
Penso che ognuno di noi porti con sé la propria cultura e le proprie tradizioni.
Pochi giorni fa, incontrando un amico compaesano per scambiarci gli auguri, il discorso è caduto sui tempi andati. Nel citare Giuànn ’a scign’ precursore dei collegamenti da e per Frontone, ho ricordato che qualche volta anch’io avevo fatto quel tratto ma o in barca, rigorosamente a remi perché non v’era alternativa, oppure, in solitario, a lente bracciate. Ho rievocato anche le traversate fatte da Giancos alla Caletta oppure verso Santa Maria passando sotto l’arco di Frisio e per la Marinella dei morti.
Lentezza ponderata e libertà di fermarsi dovunque possibile, facendo attenzione a dove poggiare i piedi, rigorosamente senza pinne (non le ho mai sopportate): su cocche chiana semi-affiorante oppure in qualche spiaggetta lungo il percorso – non esisteva alcuna restrizione! – oppure in mezzo al mare facenn’ ’u muórt’ a galla.
La libertà, inoltre, di affrontare anche un insidioso pericolo, perché ve n’è sempre uno quando ci si accinge a fare qualcosa.
Ed infatti quello si presentò sotto forma di crampo ad una gamba nel bel mezzo della Baia mentre da Giancos mi dirigevo verso la Caletta. Niente panico, ma pazienza. Pensai ad una nave con un motore in avaria. Fermai, così, le… “eliche” (le gambe) e proseguii a… “remi” (usando soltanto le braccia) riposandomi più volte facendo, per l’appunto, il…morto! Ma non tornai indietro né “virai” verso la spiaggia di Sant’ Antonio (più vicina a casa mia): proseguii, testardo, per la meta prefissata!
La libertà di movimenti può stimolare anche la libertà di pensiero, scevro da qualsiasi imposizione. E chissà se la vastità del mare e l’immensità del cielo non abbiano ispirato coloro che vi furono confinati!
Il caro amico mi ha guardato tra il meravigliato e l’incredulo. Al che anch’io mi sono stupito della sua meraviglia. Ma poi ho riflettuto. Lui è più piccolo di me di una decina d’anni e pertanto quando lui aveva l’età in cui s’incomincia a ricordare (dagli otto anni in su), qualcosa nell’Isola stava cambiando o era già cambiato dal tempo in cui io avevo la sua stessa età: dieci anni prima (nella metà degli anni ’50). Lui, infatti, tra l’altro ricordava poco di Monsignore perché il parroco della sua fanciullezza era stato don Michele Colaguori. Così credo che, nella sua fanciullezza, la Baia stava assumendo una dimensione diversa da quella di quando io avevo otto anni (dieci anni prima). Quelli della mia età e/o anche quelli più grandi di me, avevano vissuto pochi cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Mentre negli anni successivi i cambiamenti sono stati a dir poco velocissimi.
Nella mia infanzia, infatti, non esisteva ancora la Banchina Nuova per cui il mare lambiva alcune abitazioni tra cui quella dove abitavo. Non esisteva la Panoramica pertanto la spiaggia di Chiaia di Luna era, per me, del tutto fuori mano. L’energia elettrica era erogata soltanto al Porto e solo in alcune ore. Ai Conti e alle Forna gli ambienti erano illuminati ancora dalla fioca ma calda luce del lume a petrolio. Quella luce che, insieme a ’u rasiere acceso durante i mesi invernali, riscaldava un’atmosfera raccolta.
Nonna Tummtella filava la lana. Di rado parlava dei suoi trascorsi; si soffermava sui suoi animali domestici e su ciò che aveva seminato e chiudeva sempre: “Speriamo bene”. Perché il mestiere del contadino è rimasto pressoché invariato: soggetto, comunque, ai capricci delle stagioni (già in quel tempo abbastanza “capricciosi”).
Il piccolo Cardogna, il volpino, sazio delle mie carezze era sceso dalle mie ginocchia (forse un po’ scomode per lui) e beatamente era andato a prendere sonno sulla sua stuoia mentre zio Aniello era andato già a letto ’ncopp’ ’u “mezzanìn’ (soppalco), forse pensando al giorno dopo; quando, al mattino presto, insieme all’inseparabile Cardogna, avrebbe portato la pecora al pascolo su per le balze ’i Trebbiente (Tre Venti).
Ovviamente niente radio né TV con cui, si sa, oggi è impossibile intavolare un dialogo istantaneo. Essi tendono da una parte a divulgare ma anche a riempire i… “contenitori” specialmente quelli più semplici o, come dice l’arguto, “vuoti”.
Ovviamente nessun fracasso di motori; soltanto, ma a momenti, latrati di cani o ragli d’asini. Su tutto il.. silenzio parlante.
Lui, con la sua voce flebile, insegnava ad ascoltare e quindi a riflettere e soprattutto insegnava a percepire la propria voce anch’essa talmente flebile da essere facilmente sopraffatta dalla cacofonia e da quelle che tuonano ai quattro venti. Insomma insegnava ad essere se stessi!
Unico rumore: il crepitio di una bella manciata di fave secche, sgranocchiate come noccioline, dopo aver tolto la buccia divenuta coriacea poiché arrostite sotto la cenere.
Poi quella luce tremolante mi accompagnava al gran lettone, mentre l’altra stanza s’inondava di buio. Infine il buio assoluto perché nonna andava via. Dormiva, infatti, in un lettino nella stanza accanto da quando era morto nonno Raffaele.
Infine ancora silenzio interrotto dai rintocchi del pendolo che scandiva le ore.
Il gran lettone dove mi rannicchiavoa sotto le pesanti coperte quando il sibilo del vento cercava di intrufolarsi attraverso le numerose fessure degli infissi di legno tentando di vincere la resistenza dei sacchetti colmi di sabbia.
Nessuna paura, anzi quel senso di sicurezza che mi faceva scivolare dolcemente nel sonno ristoratore.
In primavera il profumo delle ginestre e dell’origano e dell’erba fresca si mescolava a quello della calce passata sui tetti delle case o sull’aia mentre dalle stalle usciva l’odore dell’umida paglia usata per concimare. Cinguettii di numerosissimi uccelli e rondini che saettavano per l’aria divorando o portando ai loro nidi mosche ed altri insetti volanti che ronzavano, anch’essi numerosi, tutt’ intorno, non abbattuti da alcun insetticida. Così, osservando, quell’Isola mi ha insegnato il rispetto per la Natura.
Le distanze, anche se brevi, sembravano enormi perché non avevo alcun termine di paragone.
Così la vecchia “Equa” (già Regina Elena) o il Gennargentu ambedue navi a vapore mi sembravano mastodontiche specialmente quando giravano (ma molto, molto lentamente perché facevano perno sulle ancore) nella baia, quasi a pavoneggiarsi e si ormeggiavano là… a’ pont’ ’u muol’, sotto la luce rossa, fioca d’u Lanternìn’.
Per non dire dell’elegante Ponza (Isola di Ponza) allorché si presentò, con gli ampi finestroni, in tutta la sua bellezza.
Solo allora la sonnolenta ma operosa comunità sembrava uscire dal suo torpore perché un piccolo gruppo di persone si radunava a’ poppa ’u vapore per salutare o semplicemente vedere coloro che mettevano piede sull’Isola. I quali, a loro volta, come soldati passati in rassegna, passavano sotto la loro… lente d’ingrandimento, dovendo transitare, (rigorosamente uno alla volta ed anche lentamente per via delle grosse valigie e/o altri pacchi) sulla stretta passerella che collegava la poppa della nave alla banchina.
Era tutto un tramestio ed un farsi avanti di parenti e/o amici mentre gli altri si facevano da parte ma restavano lì ad osservare.
Non esistendo alcun collegamento motorizzato con le Forna, non so con quali mezzi e quanto tempo impiegassero gli abitanti di quella frazione per rientrare alle loro case, specialmente chi abitava nelle zone più disagevoli e distanti. Forse con qualche barca – ’a lanz’ ’i Boms? – che faceva la spola per Cala Inferno.
E se vi era la risacca o pioveva? Comunque era un’ulteriore disagio!
Altro momento “comunitario” era ’a chiammata ’i Viciénz’ ’u pustìn’, quando una piccola folla, soprattutto composta da donne, si radunava sotto il municipio (dove era anche l’ufficio postale) e tendeva l’orecchio per sentire se per caso qualcuno fosse destinatario di una qualche lettera proveniente soprattutto dall’estero.
Momenti di attesa, per vedersi e scambiare due chiacchiere, senza fretta, anche – e perché no quelle piacevoli… a péret’ ’i ciuccio (oziose)! Farsi eventualmente due risate ma soprattutto… “commentare”!
La vastità del mare non mi faceva paura né mi rendeva prigioniero anzi acuiva la mia fantasia e/o immaginazione. E’ vero: una volta raggiunto il limite della strada o della falesia non potevo andare oltre; ero costretto a tornare indietro ma in compenso potevo percorrere, in totale sicurezza, un altro sentiero palese o nascosto, conosciuto o sconosciuto. Potevo osservare sempre nuove cose in base al terreno o alle stagioni. E ogni volta c’era sempre qualcosa di nuovo che destava in me un senso di meraviglia misto a curiosità.
Così l’ambiente non filava via veloce, come quando si viaggia in auto o in gruppo si sta dietro una guida, ma “faceva vedere” e potevo osservare, soffermandomi, anche sulle sue piccole cose. Quelle che attiravano di più la mia attenzione; la quale può essere diversa, com’è giusto che sia, da quella di un altro.
Mi sentivo protetto anche quando i marosi alti s’inerpicavano sulla Ravia o levavano alti spruzzi dietro la scogliera del Lanternino. E quando finalmente tutto quel fracasso taceva non potevi non vedere Sigarètt’ che usciva dal porto o il puntino che si affacciava là presso Zannone o i gozzi a remi che tornavano dalla pesca o uscivano per andare là dove avevano lasciato, sperando… Così, passata la tempesta, si riprende!
Quando, a martellate, si drizzava il chiodo che si era curvato nel toglierlo con la tenaglia, da qualche tavola di legno, avevi la sensazione che tutto poteva essere utile. Nulla doveva sfuggire e tu, come patella attaccata al suo scoglio, fruivi di ogni cosa, anche la più piccola, perché importante.
Quando la nera notte circonfondeva dappertutto, la Natura e l’uomo offrivano, gratuitamente, una scenografia da… Oscar: occhi a… specchio.
Lassù il firmamento più nero del carbone ma vivido perché costellato da mille “lucciole”, quaggiù il nero mare costellato da vive lampare che incorniciavano l’orizzonte verso Zannone e se anche udivi o vedevi nella penombra l’onda sonora, dalla spuma bianca, sciabordare sulla spiaggia di Sant’Antonio, quel suono era dolce a meno che non eri costretto a lasciare le calde coperte, alle tre e mezzo del mattino per andare verso “l’ignoto”.
Questo era triste, per me! Ma quella era l’ora ed era, soprattutto, un imperativo categorico perché non vi erano alternative a breve (ad esempio, qualora non si riusciva ad imbarcarsi, per andare direttamente a Formia bisognava aspettare dai due ai tre giorni!).
Qualcuno asserisce che oggi l’abbondanza e/o la facilità di alternative rende le persone meno responsabili, sia pur inconsciamente, anche nel prendere decisioni importanti. Quando, infatti, per il maltempo la nave non era giunta nell’ora e nel giorno stabilito ma faceva il cosiddetto “arriva e riparte”, lasciando gli ormeggi in pieno giorno, io, se dovevo partire, ero contento perché non ero costretto ad alzarmi a quell’ora cruda del mattino, specialmente in inverno. D’estate era meno doloroso perché già albeggiava e la nave partiva col Sole che si era levato.
Dovunque tu vai, tutto questo ed altro ancora lo porti con te: non puoi farne a meno. Puoi aggiungere altri mattoni ma le fondamenta restano quelle: ciò che la feconda Isola, anche se piccola, ti ha dato fin da quando hai aperto gli occhi nel suo seno.
Ma al momento non te ne accorgi.
Come nella maggior parte dei casi, te ne accorgi dopo, con l’avanzare degli anni, ma ci vuole ugualmente un po’ di riflessione!
Parola di Pasquale