di Patrizia Maccotta
–
Ogni anno, immancabilmente a primavera, risuona in me questo verso di Jean De La Fontaine (1621 – 1695): “Son bonheur consistait aux plaisirs d’un jardin” – La sua felicità risiedeva nei piaceri di un giardino” (1).
 Jean de la Fontaine. Le philosophe Scythe – Illustrazione G. Doré / L. Fournier (il testo della fable è in fondo all’articolo)
Jean de la Fontaine. Le philosophe Scythe – Illustrazione G. Doré / L. Fournier (il testo della fable è in fondo all’articolo)
In effetti, appena si pronuncia la parola “giardino”, ecco scorrere davanti ai nostri occhi immagini di aiuole fiorite, di viali alberati e di fontane; ci invade subito un senso di bellezza e di armonia. Non è un caso che al giardino viene associato un concetto più alto, il concetto di “paradiso”; il termine deriva dal persiano “pari-daeza” e significa “verziere”, “giardino recinto”. D’altronde, cosa era l’Eden se non un immenso giardino?
Eppure il giardino nasconde tra i fiori, insidioso, il concetto di dominio, di ordine e di potere.
Il dominio dell’uomo sulla natura ha inizio da quando egli diventa sedentario. La nascita delle prime civiltà vede, insieme alla costruzione dei templi e dei palazzi, la creazione di luoghi in cui la natura viene piegata al desiderio dell’uomo di addomesticare il mondo animale e quello vegetale. Al principio, con uno scopo puramente materiale: l’allevamento del bestiame e la coltivazione delle piante destinate alla sopravvivenza. Ma in seguito, si insinua il desiderio di plasmare la natura, di piegarla al proprio volere e di esibire, in quel modo, la ricchezza ed il potere del sovrano e delle divinità. Entra ugualmente in gioco un desiderio di ricreare un universo, un microcosmo, dove il disordine sia cancellato.
Le prime testimonianze della nascita dei giardini ci viene data da civiltà sorte su delle terre in cui non ci si aspetta certo di trovarle: in Mesopotamia e in Egitto. Tuttavia, fu proprio in quei luoghi che la presenza della palma (favorisce la condensa notturna) e le tecniche di irrigazione contribuirono alla creazione di giardini. La prima immagine di un giardino consiste nella rappresentazione sumerica di un triangolo con degli alberi. È datata 3000 anni a. C.
I faraoni della XVIII dinastia ed i loro sacerdoti crearono, nel XIV a.C. (sull’esempio di giardini asiatici di cui non abbiamo purtroppo testimonianza, se non nelle loro trasformazioni successive in giardini detti “persiani”), una tipologia di giardini che illustrava la loro ricchezza ed il loro potere. Situati presso il palazzo o presso il tempio, essi comprendevano una vasca d’acqua con piante acquatiche e dei viali bordati da sicomori. La disposizione geometrica della vasca e dei viali illustrava ugualmente un desiderio di ordine, essendo da sempre l’ordine insito nel potere.
Poco prima, alla fine del XIII secolo, in Mesopotania, il re Sargon di Akkad, nei suoi annali, ci descrive il giardino che ha creato vicino alla sua capitale, Ninive, dove ha riunito tutte le essenze dei paesi che ha conquistato. Un giardino che diventa, pertanto, il simbolo della sua forza militare.
 Il Giardino di Nebamun. Affresco del 1380 a.C., della tomba di Nebamoun a Tebe, ora a Londra, al British Museum
Il Giardino di Nebamun. Affresco del 1380 a.C., della tomba di Nebamoun a Tebe, ora a Londra, al British Museum
Alcuni secoli più avanti, un altro sovrano, Nabucodonosor (regno: 604 a. C. – 562 a. C.), nato a Uruk e morto a Babilonia, fece costruire per la sua giovane sposa meda (antica Persia nord-occidentale), che aveva nostalgia della natura del suo paese, quello che venne classificato come una delle sette meraviglie del mondo: il giardino pensile di Babilonia.
Non è documentato da alcun testo cuneiforme e non se ne hanno rappresentazioni, ma ci viene descritto, secoli dopo dal poeta Antipatro da Sidone (170 a. C. – 100 a. C.), non si sa sulla base di quali fonti: “Ho posto gli occhi sulle grandi mura di Babilonia antica (…) ed i giardini pensili (…)”. Un giardino concepito per amore, allora? No, anche in questo caso un giardino simbolo del potere che racchiude le essenze vegetali dei paesi conquistati.
Nelle epoche successive, i giardini persiani furono impiantati per rispondere al desiderio di mettere ordine nell’universo, ricreandolo e dividendolo, simbolicamente, in quattro parti separate da assi ortogonali, con un palazzo o una fontana che si erigeva all’intersezione dei due assi; il mondo ellenico non diede molto spazio al giardino realizzando la sua idea di ordine e di potere nelle architetture e preferendo gli orti ed i boschi sacri; nel mondo romano, il giardino riacquistò la sua funzione di illustrare la potenza e la ricchezza della classe aristocratica.
Ed ecco che le ville suburbane saranno circondate da splendidi spazi verdi dove, sotto il governo di Augusto, le mani sapienti del “topiarius”, lo schiavo paesaggista che vegliava sulle piante, tirannizzeranno il bosso, l’alloro, i cipressi ed i pini, costruendo in modo iperbolico l’esibizione di un potere legato ad un ordine assoluto.
Nel medioevo, l’arte dei giardini conobbe in occidente una lunga eclissi. Il giardino venne relegato nei monasteri ad un ruolo subalterno: vi si coltivavano alberi da frutta e “semplici” a scopo medico. La tecnica paesaggistica venne, tuttavia, mantenuta viva nei paesi di lingua romanza e, nel XIII secolo, riappaiono le bordure di bosso e si piegano i tigli per formare dei viali coperti. Si fanno arrampicare le rose su armature a forma di ruota. L’uomo riprende la sua conquista della natura.
I miniaturisti francesi illustrano i giardini dei romanzi cortesi e riappare il gusto per i giardini dei paesi caldi sul modello di Cordova e di Granada.
Le leggende di re Artù sono popolate di giardini meravigliosi e Guillaume de Loris descrive creazioni vegetali nel suo “Roman de la rose”.
Il dominio dell’uomo sulla natura diventerà comunque totalizzante a partire dal Rinascimento, per conoscere la sua apoteosi nel XVII secolo, con il parco classico della reggia di Versailles (immagine qui sotto).
Il modello rinascimentale si realizzò in Italia in uno spazio chiuso. La Francia prolungherà questo spazio aprendolo sulla natura circostante e adornandolo con costruzioni vegetali. Un quadro di Andrea Mantegna ( 1431 – 1506 ), che si trova al Louvre, mostra già, anni prima, un prototipo di queste costruzioni fatte di alberi potati che annunciano les charmilles (i pergolati) di Versailles.
 Il Trionfo della Virtù (o Minerva scaccia i Vizi dal giardino della Virtù) di Andrea Mantegna, completato nel 1502. Al Louvre di Parigi
Il Trionfo della Virtù (o Minerva scaccia i Vizi dal giardino della Virtù) di Andrea Mantegna, completato nel 1502. Al Louvre di Parigi
Numerosi esempi di giardini rinascimentali ci vengono offerti dalle lunette delle ville medicee di Giusto Utens. Una rigorosa geometria disciplina la natura, mette ordine nella sua sovrabbondanza e la piega al desiderio del principe.
Così ci raccontano i giardini di La Pretaia, di Castello, di Pratolino , di Poggio – nella campagna toscana – e di Boboli a Firenze e quelli di Bagnaia, di Caprarola, di Vignanello e di Frascati (la Villa Aldobrandini dove gli scherzi dell’acqua e la presenza delle vasche si espanderanno nel grand bassin di Versailles) nel Lazio.
E così ci racconteranno il giardino del Belvedere elaborato dal Bramante (1444 – 1514) in Vaticano ed il giardino elaborato da Pirro Ligorio (1512 – 1583) per il cardinale d’Este a Tivoli.
 I giardini di villa Lante a Bagnaia (VT), visti dal piano nobile
I giardini di villa Lante a Bagnaia (VT), visti dal piano nobile
Sono tutti giardini che esaltano la ricchezza e la grandezza dei loro committenti.
In Francia i giardini all’italiana saranno imitati ed esasperati a Chambord, Blois e Villandry dove les broderies (i ricami) floreali si faranno ancora più precise. Ma è in due parchi vicini a Parigi che nel XVII secolo, il grande siècle classique, il potere si esprimerà in una lotta crudele.
Il sovrintendente di Luigi XIV, Nicolas Fouquet (1615 – 1680), sfiderà la grandezza del suo re creando a Vaux-Le-Vicomte, tra il 1656 e il 1661, insieme allo stesso architetto che servirà il sovrano, André Le Notre ( 1613 – 1700), un castello ed un giardino che saranno l’emblema del suo posto nell’alta aristocrazia francese. Il parco, adagiato su tre piani che degradano dolcemente verso il torrente Angueil, inquadrato da grandi alberi, sarà colorato da una distesa di aiuole di broderies e si rispecchierà in grandi vasche d’acqua.
La Fontaine, sempre lui, ha trovato il modo di presentare l’incanto di quel giardino:
“Due incantatori pieni di sapere
Fecero tanto con la loro impostura
Che si credette avessero il potere
Di dare ordini alla natura”.
Ma un tale sfoggio offuscava l’immagine del monarca. Dopo una festa magnifica tra le piante ed i fiori di Vaux, Luigi XIV accusò Fouquet di peculato e di lesa maestà; lo fece arrestare dai suoi moschettieri (tra cui D’Artagnan). Il sovrintendente fu condannato al carcere a vita e rinchiuso nella fortezza di Pinerolo, in Piemonte. Venne in seguito liberato, ma morì poco dopo, pare avvelenato. La leggenda lo identifica con la Maschera di ferro.
Il castello e il parco di Vaux le Vicomte
Un giardino pericoloso il suo, che il re invidiò e prese a modello per costruire il parco intorno alla nuova reggia voluta per tenere tutta la nobiltà sotto il suo diretto controllo. E siccome il sovrano era l’incarnazione del potere assoluto, egli sfidò ancora di più la natura scegliendo un terreno paludoso e malsano per trasformarlo in un enorme spazio teatrale che circondava una residenza maestosa. Questo complesso divenne un modello per tutte le monarchie d’Europa.
Questo ci narrano i giardini celebri dove i grandi della terra hanno provato “le plaisir superbe de forcer la nature, il piacere superbo di forzare la natura (Saint-Simon, 1675 – 1755). In Europa e nelle altre parti del mondo.
Più legati alla spiritualità i giardini giapponesi che necessitano, tuttavia, di un altro racconto.
Lentamente, nel XVIII secolo, soprattutto in Inghilterra, i giardini si adattarono al paesaggio naturale che non fu più compresso, ma solo guidato.
Nel XIX secolo i giardini lentamente si sono democratizzati; si sono trasformati in uno spazio pubblico ed hanno abbandonato il loro ruolo di vetrina del potere.
Note
(1) – Jean De La Fontaine (1621 – 1695), si presenta come il continuatore di Esopo e Fedro e il discepolo di Epicuro; ha spesso intenzioni morali e la satira e il contrasto sono fra i suoi metodi preferiti. Nella favola Le philosophe Scythe mette in risalto come l’applicazione indiscriminata dello sfrondamento e della potatura, malamente appresi e trasferiti dal mondo naturale a quello dei sentimenti sottraggono al cuore i dolci stimoli e gli incanti
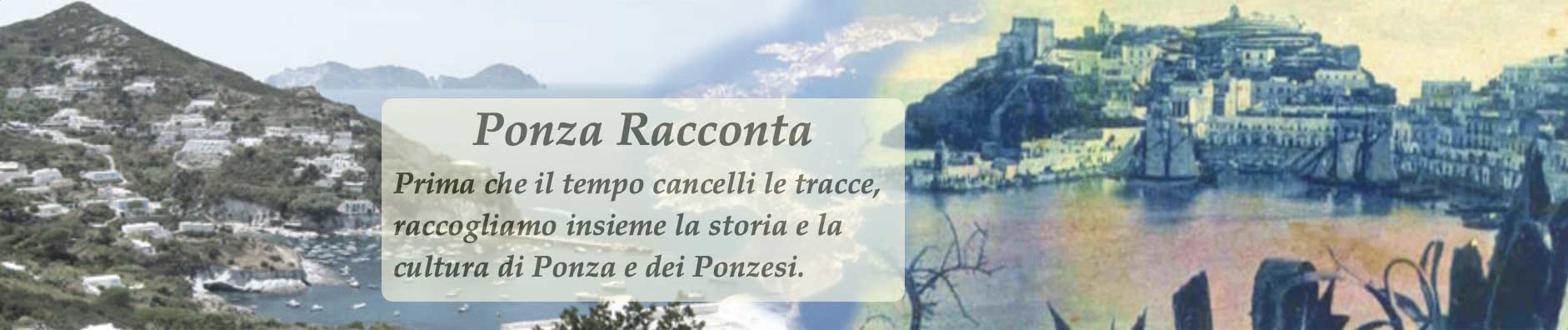











Tano Pirrone
21 Aprile 2022 at 10:12
Ils font cesser de vivre avant que l’on soit mort. (Ci fanno smettere di vivere prima di morire); dice l’ultimo verso, ricordando che l’abbandono e le pessime cure fanno danni prima a noi che alle piante stesse. Il gentile signor La Fontaine non avrebbe scritto la bella composizione che ho letto nella sua interezza, aiutandomi con un buon vocabolario, se avesse conosciuto Roma e i servizi di giardinaggio che da trent’anni massacrano il suo magnifico verde… la scorsa settimana blocco del traffico in viale Regina Margherita e nel suo naturale prolungamento verso i Parioli, il viale Liegi: dovevansi potare gl’immensi platani, ma le bande sono state bloccate da vibranti proteste, perché quegli alberi non si potano ad aprile: non si fa un’appendicectomia con un calzascarpe, insomma.
Smetto le lagnanze e mi congratulo con la mia cara amica Patrizia per il bell’articolo, informato, stimolante, mai noioso e. soprattutto, evocatore: giardini! Gli esecrati arabi vennero in Sicilia e la colonizzarono: cioè, vi si impiantarono in modo stabile e vi profusero impegno e ricchezze, visione della vita e dell’aldilà. Diedero subito un nome ad ogni cosa che riguardasse la terra, i luoghi; perché le cose devono avere un nome, che identifichi esse e la loro relazione con il mondo: dare un nome alle cose significa farle esistere. I nomi, infatti, sono preziosi quanto le cose, i pensieri che indicano. Secondo Walter Benjamin, il rapporto che intratteniamo con le parole è così intimo da rasentare l’immedesimazione. «L’uomo», scriveva il filosofo tedesco, «comunica la propria essenza spirituale nella sua lingua». Così gli Arabi portarono gli aranci e li coltivarono, portarono altre essenze e le coltivarono e chiamarono queste piantagioni: giardini. Centinaia e centinaia di anni sono scorsi, ma quel termine non è finito, è rimasto nella cultura dei figli dei figli degli arabi, che con pazienza ed amore hanno coltivato gli aranci, lì, nei “giardini”, il luogo in cui si fanno crescere, si allevano piante, che producono fiori, frutti, ricchezza, e il benessere del rapporto amichevole e pieno di gratitudine verso il popolo delle piante: Ils font cesser de vivre avant que l’on soit mort.
Ora mi trascino in terrazza, anche per poco, vado a raccontare alle mie piante del tuo articolo e leggo loro la mia risposta: speriamo che me la cavo. A presto!