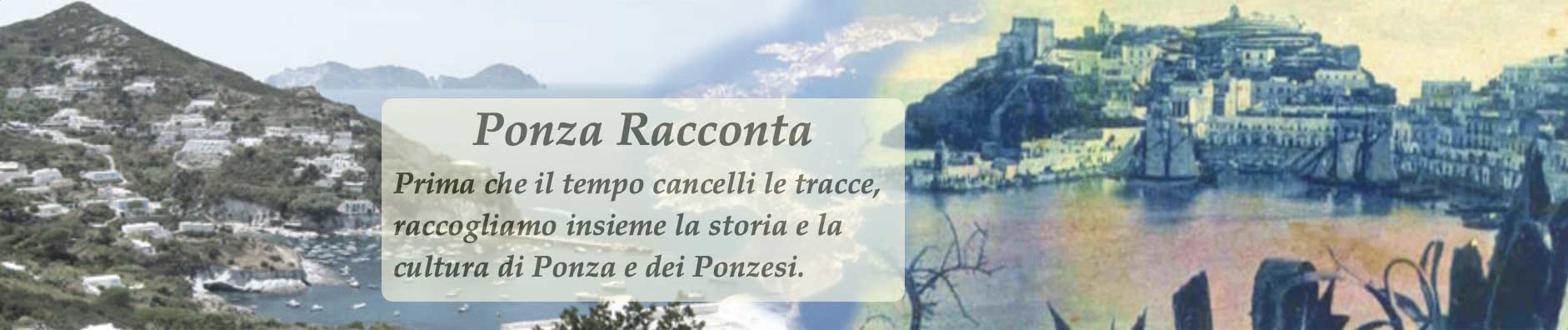a cura della Redazione da la Repubblica di ieri
.
Estratto dall’articolo di Michele Bocci da la Repubblica del 12 febbr. 2025, pag. 2
“(…) La Toscana, dopo che la maggioranza ha emendato alcuni passaggi della legge di iniziativa popolare proposta dall’associazione Coscioni, stabilisce adesso da quali professionisti debba essere costituita la Commissione multidisciplinare che dovrà, insieme al Comitato etico locale, dare una risposta all’istanza del malato entro 20 giorni. Se l’esito è positivo, entro altri 10 giorni va definita la modalità di attuazione del suicidio e entro altri 7 la Asl deve dare gratuitamente il farmaco e mettere a disposizione il personale. Per queste prestazioni c’è uno stanziamento da 10mila euro all’anno per tre anni. Sono stati poi approvati ordini del giorno che prevedono di valorizzare le cure palliative e chiedono un intervento legislativo nazionale. (…)
L’analisi
Diritti, l’ostilità della politica
di Luigi Manconi – Da la Repubblica del 12 febbraio 2025
L’esperienza del dolore, scriveva Thomas Bernhard mezzo secolo fa, costituisce il tratto più autentico della dimensione umana: più di quanto lo siano l’aspirazione alla libertà e il senso del piacere. Questo forse può aiutare a comprendere come mai la domanda di lenimento, di attenuazione e di rimozione delle sofferenze, dovute alle patologie cliniche e al degradare del corpo e dello spirito, sia così intensa e tenace, attraversi le vite individuali e l’organizzazione sociale, eroda convincimenti consolidati e opzioni etiche e religiose sedimentate. E trovi vie inedite per affermarsi: ieri il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a larga maggioranza la proposta di legge, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, destinata a regolamentare la procedura per accedere al suicidio medicalmente assistito.
È possibile che altre regioni, alcune delle quali amministrate dal centrodestra, procedano nella medesima direzione. Ma lo stato presente delle cose, delle idee e delle emozioni appare ancora più inquieto.
Qualche giorno fa, Michele Brambilla, direttore di Il Secolo XIX e uomo di fede, ha raccontato, con struggente sobrietà, come nel 2009 avesse fortemente criticato la decisione dei genitori di Eluana Englaro di porre fine all’esistenza della figlia, in stato vegetativo permanente da diciassette anni. Successivamente sarà la «cognizione del dolore», nel significato più sottile del testo di Carlo Emilio Gadda, a far mutare l’orientamento di Brambilla: posto di fronte alla necessità di scegliere, per la propria madre, tra l’autorizzazione a un intervento chirurgico altamente rischioso e la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali, optò per la seconda ipotesi. Da questa decisione così personale e così radicalmente morale, il proposito di «non giudicare più nessuno».
Sembra essere questo il sentimento che percorre la mentalità collettiva del nostro paese, inducendo la maggioranza dei cittadini a dirsi favorevole a un provvedimento che riconosca e regolamenti il diritto dell’individuo all’autodeterminazione e alla «sovranità su di sé e sul proprio corpo» (John Stuart Mill).
Un sondaggio periodico, condotto su base scientifica, conferma che tra gli abitanti del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, la quota di quanti vorrebbero una legge sulla eutanasia è cresciuta di 25 punti percentuali in vent’anni, raggiungendo l’81 per cento nel 2022. E tutte le ricerche indicano come sull’intero territorio nazionale prevalga la medesima tendenza.
A fronte di ciò l’atteggiamento della classe politica risulta persino più estraneo e lontano di quanto una tradizione di pervicace insensibilità possa far immaginare. Nel novembre del 2019, la sentenza 242 della Corte costituzionale ammise la possibilità dell’aiuto al suicidio assistito e indicò i quattro requisiti per accedervi (patologia irreversibile, sofferenza fisica o psicologica non tollerabile, capacità di esprimere un consenso libero e consapevole, trattamento di sostegno vitale). E chiese al parlamento di legiferare in materia.
Una successiva sentenza della Consulta (luglio 2024) ha ampliato le condizioni in cui ricorrerebbe la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale, e ha rinnovato — con parole nette — la richiesta di una normativa parlamentare in proposito. Dopodiché nulla è stato fatto. Da qui la «mossa del cavallo» adottata dall’Associazione Luca Coscioni, per aggirare quel blocco di potere rappresentato dall’abdicazione del parlamento, e l’iniziativa all’interno dei consigli regionali.
L’inerzia del parlamento, manifestatasi anche durante i governi di centrosinistra, si deve a più ragioni. La prima risiede in un colossale equivoco culturale: l’idea che si tratti di questioni non politiche, se non (con un linguaggio polverosamente datato) «sovrastrutturali», e comunque non urgenti. Quasi che vi fosse qualcosa di più politico e di più urgente dell’affrontare una sofferenza non sedabile, che può raggiungere o comunque lambire tutte le famiglie e le comunità.
La seconda ragione si trova nella sottovalutazione del peso del dolore nell’esistenza e nella soggettività delle persone. Una parte significativa della classe medica esita a considerare il dolore come una vera e propria patologia e lo annovera piuttosto tra gli effetti collaterali e in qualche misura inevitabili della causa primaria di infermità. Ma c’è soprattutto, e si va rafforzando, un orientamento politico ostile alla regolamentazione per legge del fine vita. È una tendenza schiettamente reazionaria che trova il suo punto di forza nel partito di Fratelli d’Italia, mentre qualche breccia non secondaria si va aprendo nella Lega.
Paradossalmente, una simile posizione si rivela più arretrata di quella, alla quale strumentalmente si richiama, espressa dalla Chiesa cattolica. La sua pastorale, infatti, ha conosciuto profondi cambiamenti.
Dalle parole sorprendentemente anticipatrici di Pio XII nel 1957, passando attraverso la drammatica invocazione di Giovanni Paolo II («lasciatemi andare alla casa del Padre»), il cammino della Chiesa appare più spedito di quello di tanti «atei devoti». I parlamentari cattolici hanno avuto un ruolo rilevante nell’approvazione della legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (2017), che prevedono, tra l’altro, la possibilità di sospensione di nutrizione e idratazione artificiali. E il metodo della sedazione profonda che accelera il fine vita è ormai considerato accettabile dalla stessa dottrina.
Intanto, la politica resta a guardare, con viso grave e compunto, mormorando: «Si tratta di temi eticamente sensibili». Ma se la politica si mostrerà ancora una volta incapace di chinarsi al capezzale di chi urla «il dolore della carne», il suo fallimento sarà irreversibile.
[Luigi Manconi – Da la Repubblica del 12 febbraio 2025]
Note (a cura della Redazione)
Lettura consigliata:
 Thomas Bernhard (1931 – 1989), Gelo (Frost; 1963), Adelphi (1986), pagine 356
Thomas Bernhard (1931 – 1989), Gelo (Frost; 1963), Adelphi (1986), pagine 356
Da doppiozero.com: recensione di Massimo Marino: Thomas Bernhard il dolore e la neve.pdf :
“Strauch, il pittore Strauch, mentre il fratello gode di riscontri e successi presso il consesso scientifico e la buona società, si perderà nella neve: “Ritornato a Schwarzach ho letto sul ‘Demokratisches Volksblatt’: ‘Da giovedì della scorsa settimana tale G. Strauch di W., senza professione, risulta disperso nella regione di Weng. Le operazioni di ricerca, alle quali partecipavano alcuni agenti della gendarmeria, sono state interrotte a causa delle intense nevicate’”. Perso nel gelo della disperazione pura, del grande vuoto esistenziale.