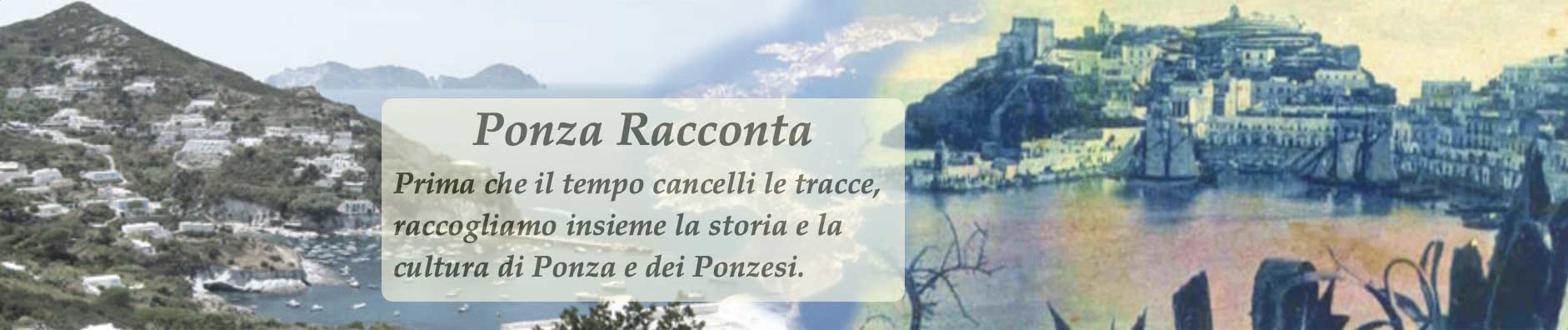di Giuseppe Mazzella
Tasse, contributi, imposte di ogni genere, balzelli comunali, regionali e nazionali accompagnano la vita dei cittadini per tutta la vita. Un peso che a volte si rende insostenibile e che fa perdere il sonno a tanti.
Ma è stato sempre così?
L’imperatore Tiberio ne era convinto: «I veri pastori di popoli – affermava – debbono saper tosare le loro pecore senza scorticarle».
Imposte, tributi, balzelli, dazi, pedaggi, gabelle: in qualsiasi modo siano chiamate, le tasse sono sempre state per sudditi e sovrani una ossessione. Quello di distribuire equamente le imposte, infatti, è un’abilità inscindibile dalla difficile arte del potere: ecco perché il genio della fiscalità è un’abilità tra le più creative. Una fantasia nella quale si sono sbizzarriti abbondantemente faraoni e re, imperatori e papi, nobili e condottieri di ogni epoca. Una pratica antichissima e raffinata che ha invaso quasi ogni aspetto della vita, in una gara infinita che tante lacrime ha fatto versare e tante sommosse e sedizioni ha originato. Non vi è paese o periodo della storia che non abbia conosciuto, specie nei momenti di ristrettezze, le torture del fisco. Ma esiste anche una storia minore nella quale la crudezza dei tributi è stata se non nobilitata almeno alleggerita dall’estrosità degli ideatori. Ecco allora il fiume delle “imposte bizzarre”, nel quale il balzello, perduto il primitivo carattere saltuario, “a sbalzi” appunto, si manifesta ormai come un’onda che tutto avvolge.
«Tassate, tassate, qualcosa resterà!»: il grido del legislatori fiscali risuona dall’antichità fino ai nostri giorni. Tasse sul macinato, sul pedaggio, sul pescato, sul trasporto, sulla sepoltura, e su ogni aspetto spesso minimo delle attività umane, sono state contrastate dai tentativi di sottrarsi alla secolare “persecuzione”. Vi riuscì, ma solo per pochi mesi, Masaniello nel 1647, insorgendo contro il governo spagnolo e, più vicini a noi, Gandhi con la sua “disobbedienza” non violenta.
Dalla più remota antichità i popoli hanno pagato le tasse, costituite inizialmente da parte del raccolto agricolo. Col passare del tempo la “macchina fiscale” è diventata sempre più sofisticata e invadente. Una mannaia che in alcuni casi ha decimato popolazioni e asservito civiltà. Già Pescennio Nigro, rivale di Settimio Severo per la conquista del trono imperiale, quando era governatore in Siria, alla richiesta degli Ebrei di alleggerire le tasse, rispose: «Vorrei, se potessi, farvi pagare anche l’aria che respirate!». Tassare l’aria, vecchio ma ancora irrealizzato sogno di ogni legislatore fiscale, minaccia oggi di essere un traguardo a portata di mano.
Da sempre le imposizioni tributarie sono state mal tollerate. Un poeta greco, del quale non conosciamo il nome, si lamentava in una poesia che «persino Caronte aveva fatto salire a tre oboli, invece di uno, la tassa che dovevano pagargli i morti per essere traghettati sulla sponda di Acheronte».
Durante la seconda guerra punica fu introdotto per la prima volta la tassa sul sale, una decisione che destò forte malumore, procurando al censore Livio, ideatore della imposta, il soprannome di “Salinatore”.
Tra le tasse più curiose va certamente ricordata quella sulla “omissione”, geniale ed esilarante trovata di Guglielmo Il d’Inghilterra. Era il 1095 quando il re, in ristrettezze finanziarie, ordinò la mobilitazione di ventimila uomini col pretesto di invadere la Normandia. Quando la truppa fu pronta per imbarcarsi, chiese ad ogni soldato dieci scellini per evitare l’arruolamento, tutti furono felici di pagare pur di sottrarsi alla guerra. Poi il re li congedò!
Tasse contro i vizi umani: una “brillante” idea di papa Giovanni XXII che previde per la remissione di ogni peccato una tariffa diversa. Le entrate furono tanto rilevanti – ha scritto lo storico Gregorovius – da fruttare alla Chiesa un tesoro di venticinque milioni di fiorini d’oro. Anche un altro papa, Sisto V, fu considerato abilissimo nell’ideare nuove imposte. Durante il suo regno, dopo un’ abbondante pioggia, al collo di Pasquino, la famosa “statua parlante” romana, venne trovato un cartiglio nel quale era scritto che «stava asciugandosi in fretta prima che fosse posta una tassa sui raggi del sole».
L’idea di colpire un vizio come la maldicenza fu sostenuta dal famoso scrittore Giovanni Swift, il creatore dei Viaggi di Gulliver e dal1’abate Cayer, un francese di bello spirito, che calcolò avrebbe fruttato all’erario non meno di venti milioni all’anno.
Anche Pietro il Grande non volle essere da meno in bizzarrie, introducendo l’imposta sulla barba. Molti sudditi, specie quelli più ricchi, fecero a gara a mostrare l”’onore del mento”, disposti a sborsare fino a quaranta rubli. Per garantire la totale esazione, veniva rilasciato al momento del pagamento un gettone di bronzo che ogni cittadino barbuto doveva portare sempre con sé e mostrare al controllo della polizia. Chi ne risultava sprovvisto veniva sbarbato seduta stante.
Dalle barbe alle parrucche e siamo al 1715, quando il Duca di Parma, Francesco Maria Farnese, introdusse con ottimi risultati una tassa sulle parrucche. Il nuovo tributo gravava “democraticamente” sia sugli uomini che sulle donne.
Ancora qualche decennio e il Consiglio comunale di Bruges introdusse la tassa di dieci lire per ogni water-closet. Una misura che andava a colpire soprattutto le classi più abbienti, dal momento che le famiglie povere ne erano quasi tutte sprovviste.
Tutti conoscono le tasse che in ogni Paese sono state poste sul tabacco e sull’alcool; meno note sono quelle sulla letteratura. Nel 1892 il pubblicista americano Wolff How, propose sulle colonne del North American Review una tassa sulla novellistica che, «poteva ritenersi – scriveva – un bene voluttuario al pari del fumo, e con effetti altrettanti nocivi sulla salute delle persone». Una proposta ripresa dal poeta francese Mallarmé che propose addirittura di pagare diritti d’autore su opere ormai svincolate. Le imposte – dichiarava – dovevano essere versate all’erario dei paesi originari degli autori. Un’idea prontamente ripresa dal governo greco, ma immediatamente ridicolizzata, che pretendeva di tassare le ristampe in tutto il mondo delle opere di Omero, Euripide, Eschilo, Aristotele, Platone e via dicendo.
Sempre in materia di diritti d’autore va ricordata l’imposta sui libri, provenienti dall’estero, voluta nel 1823 dal re borbonico. Il libraio francese Borel, che aveva un negozio a Napoli fu costretto a pagare su ogni volume importato dalla Francia 1.32 lire per i libri in ottavo, 2.64 per quelli in quarto e 3.96 per quelli in folio. Quando si dice tutela della cultura!
Tra le imposte più strane non è possibile dimenticare quella sul celibato, la prima delle quali fu “inventata” negli Stati Uniti d’America. Chiunque avesse compiuto ventotto anni – recitava la norma – era tenuto a pagarla, a meno che non dimostrasse di aver avuto almeno due rìfiuti di nozze da parte di altrettante signorine. Ad opporsi, tra gli altri, ci fu un tale Tom Hardy, celibe impenitente, che si rifiutò di pagare adducendo le ricevute di due raccomandate alle quali non aveva ricevuto risposta: le maleducate erano la signorina Gould, figlia del celebre inventore Edison e la principessa lolanda di Savoia!
Anche in Francia venne introdotta nel 1913 la tassa sulla sterilità, nota come imposta sugli “improduttivi”, quelli cioè che davano alla patria meno di tre figli. Sulla stessa linea negli anni Settanta venne presentata, nel Rodhe Island degli Stati Uniti, una proposta di legge che prevedeva l’imposizione di una tassa di due dollari su ogni atto sessuale che avesse avuto luogo entro i limiti territoriali dello stato.
Come non ricordare la famosa “tassa sul celibato” nel ventennio mussoliniano. Era composta da un contributo fisso che variava a seconda dell’età: di 70 lire per i giovani tra i 25 e 35 anni; 100 lire fino ai cinquant’anni, per ridursi a 50 se si superava tale età e la totale esenzione dopo i 66.
Ai nostri giorni nuove e sempre più sofisticate imposte stanno “considerando” balconi, fioriere, loculi cimiteriali, funerali nello spazio e persino proprietà terriere… sulla Luna. Quello che appare certo è che la fantasia dei nuovi legislatori fiscali, che continuano a non conoscere crisi, continua a cozzare contro l’indomita resistenza dei contribuenti. Una vecchia dizione notarile precisa che un atto “sconta” l’imposta. Forse in questo verbo dal tono scopertamente “penitenziale”, sta il succo di tutta la storia.
Oggi come ieri le tasse somigliano troppo ad una condanna alla quale ognuno cerca di sfuggire.
NdR: nell’immagine di copertina L’ufficio delle tasse di Pieter Brueghel il Giovane, detto Brueghel degli Inferi (Bruxelles, 1564 – Anversa, 10 ottobre 1638), pittore fiammingo attivo a cavallo tra il XVI e il XVII