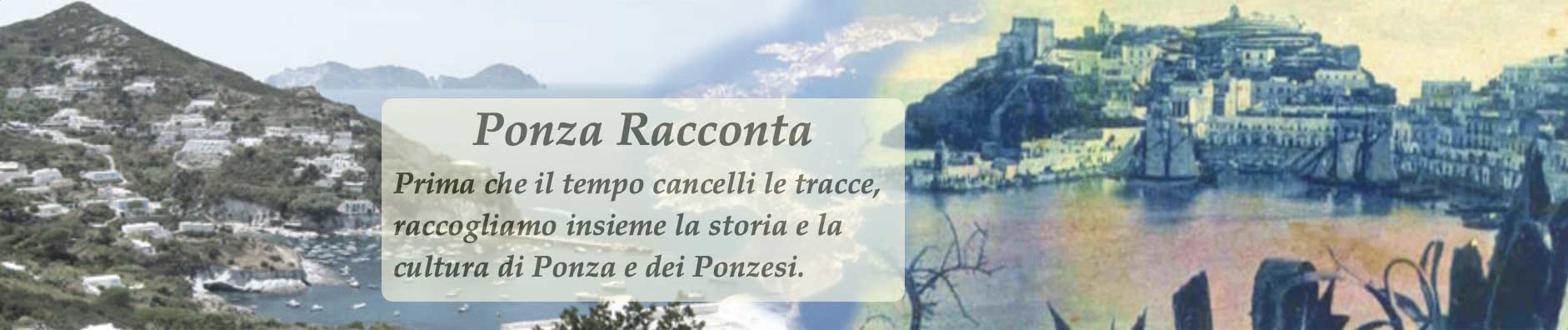.
Quest’anno molti turisti/pellegrini visiteranno la città eterna anche per oltrepassare le porte sante. Essi probabilmente vagheranno dappertutto per ammirare i vetusti monumenti, palazzi e chiese sparsi un po’ dovunque. Dappertutto potranno leggere, oltre ai nomi dei Pontefici in bella mostra sugli architravi delle chiese, anche l’acronimo : S.P.Q. R. Si suole tradurre come Senatus PopulusQue Romanus (il senato ed il popolo romano).
In realtà non è proprio così perché la “Q” di que (parte finale di populus) è una semplice congiunzione enclitica. Allora cos’è la “Q”? Non è altro che la parte iniziale della parola Quirites che vuol dire Sabini.
In epoca storica, infatti, i Romani erano chiamati anche Quirites e Romolo, salito al cielo durante una tempesta, assunto tra gli dei, stranamente cambiò radicalmente il proprio nome: assunse infatti il nome di Quirino!
Perché, allora, gli stessi antichi Romani accettavano la Q come congiunzione? Perché, come sempre, non volevamo ammettere la sonora… sconfitta subita per l’appunto dai Quirites e cioè dai Sabini.
Nell’acronimo, pertanto, le parole sono messe in ordine di importanza. Prima di tutto il Senato cioè gli anziani: l’esperienza. A seguire il Popolo cioè coloro che vanno a combattere; quelli che, inoltre, da sempre rappresentano il futuro: i giovani. Poi i vincitori: I Quirites/Sabini ed infine gli sconfitti: i Rumon; parola etrusca che vuol dire fiumaroli/barcaioli.
Anzi penso che in origine quell’agglomerato di capanne (case) non si chiamasse neppure Roma ma aveva qualche altro nome Sabino (forse città dei Quiriti). Come andarono, quindi, i fatti?
I Quirites/Sabini al potere
Oggi passeggiando per Roma notiamo salite e discese ma quasi quasi non ce ne accorgiamo sia perché siamo circondati da palazzi sia perché nel tempo questi sono sorti al di sopra di altre strutture (così come avviene dappertutto). Quindi la Roma antica sta ben al di sotto dell’attuale agglomerato urbano. Ma se con l’immaginazione ci rechiamo nell’VIII sec. a.C. notiamo delle alture (colline) e degli avvallamenti pieni di boschi e sterpaglia. In mezzo ad alcuni di questi avvallamenti ci passa un fiume che spesso straripa e li occupa, per cui le persone che abitano in quelle zone, chiaramente preferiscono stare sulle alture. Questo fiume, però, costituisce, a sud, impedimento al commercio degli Etruschi verso le colonie della Magna Grecia. In mezzo a questo fiume vi era e vi è un’isola che ne agevolava in qualche modo l’attraversamento. Quello era il punto più… comodo. Ma sull’altura ad essa più vicina (quella che in seguito fu chiamata Palatino) si erano arroccati un gruppo di Latini che forse avevano scacciato un gruppo di Etruschi/Greci. Ma questi ultimi si erano andati a stanziare su un vicino colle chiamato Celio (Caverna). La cima del Palatino, inoltre, era composta da tre propaggini (Palatium, Germalus e Velia più in basso) quindi facilmente difendibile. Esso faceva parte del “septimontium” (i sette colli, quelli… originari). La rimanente parte di questi sette colli era costituito dall’Esquilino che aveva anch’esso tre propaggini (Cispius, Oppius e Fagutal) ed infine il Celio.
I Rumon/latini facevano affari con coloro che volevano attraversare il fiume o meglio li taglieggiavano. Durante la stagione propizia (la primavera), per ordine di un Pontifex (pontefice: colui che ordina di costruire il ponte),costruivano anche una sorta di ponte tibetano. Il Pontifex, infatti, era l’unico che, non esistendo alcun calendario, conosceva l’alternarsi delle stagioni. Gli etruschi, pertanto, cominciarono ad apostrofarli con il nome di Rumon (fiumaroli/barcaioli).
“Da dove passi o dove vai? – chiedeva l’etrusco Porsenna.
“Passo o vado dai Rumon” – rispondeva un tal Vibenna.
E così, com’era successo quando i Greci si recavano nella terra degli Ituli (coloro che adoravano il vitello), da cui poi prese nome tutta la Penisola, anche quella zona cominciò a chiamarsi Terra dei Rumon: cioè Roma. Ma non in modo, oggi diremmo, ufficiale. Come mai?
Come è accaduto da sempre e purtroppo accade ancora oggi, quando ci sono interessi economici, scoppia un conflitto armato, così quegli introiti facevano gola ad un altro gruppo di persone che abitavano non molto lontano. Costoro appartenevano ad una tribù sabina, chiamati Quirites. Abitavano su un altro colle un poco più distante dal fiume, che poi si chiamerà Quirinale. Questi venuti alle mani con i Rumon (latini), li sconfissero e li sottomisero. Ciò è dimostrato dal fatto che, dopo il cosiddetto ratto della Sabine (probabilmente in precedenza vi erano, già, stati matrimoni combinati ed i litigi in famiglia per interessi economici non sono mai mancati), Romolo, come già detto, sia sparito, assumendo il nome di Quirino, mentre il re sabino Tito Tazio rimase al suo posto. Quindi tutti gli abitanti cominciarono a chiamarsi Quirites.
I vincitori, preso il potere, imposero le loro leggi ed i loro costumi (Numa Pompilio, fu un re sabino).
Erano famiglie dedite all’agricoltura e all’allevamento. I nomi delle più antiche gens (i Patres da cui patrizi) infatti, rispecchiano queste attività, come ad esempio quella della Gens Fabia (da fava). Ed anche in epoca storica costoro rifuggivano da altri lavori, affidando il commercio e l’artigianato prima alla plebs e poi ai liberti. Costoro imposero un governo aristocratico (oggi diremmo “di destra”). Esso s’imperniava sull’osservanza degli usi e tradizioni prettamente orali. Così le potevano interpretare e gestire a modo loro e soprattutto a danno dei Rumon e degli Etruschi. I quali, però, abitando vicino al fiume continuavano a gestire i traffici; ma buona parte dei loro introiti andavano nelle casse dei Quirites.
I Rumon e gli Etruschi al governo
Quando il commercio si incrementò, i Rumon insieme con gli Etruschi fecero sentire la loro voce. Questi ultimi, più esperti negli affari di governo, presero il potere con la violenza. Ciò è dimostrato dai frequenti delitti, documentati anche da alcuni affreschi rinvenuti a Vulci. Ma non mi dilungo su questi episodi perché un po’ complessi. Essi, scacciando dal potere i Quiriti ed essendo in pochi rispetto alla restante popolazione, non potevano non appoggiarsi che al dinamico ceto dei fiumaroli: i Rumon per l’appunto. Pertanto costrinsero i Patres Quirites ad adottare la lingua di quelle persone (il latino), e chiamarono definitivamente quell’ agglomerato di capanne/case: terra dei Rumon, cioè ROMA.
A dimostrazione dell’appoggio per la classe dei commercianti essi divisero la popolazione in base alla ricchezza (censo) ed attuarono tutte quelle migliorie che servono per l’appunto a tutto il popolo, anche alle classi meno abbienti: strade, ponti, fogne, porti. Prosciugarono gli acquitrini (tra l’altro il campo Boario dove ammassavano il preziosissimo sale che proveniva dalla foce del Tevere) e costruirono la piazza (il Foro). Oggi diremmo, con tutti i limiti delle analogie temporali, un governo più di… sinistra).
Anche i costumi divennero più… liberi (sempre in rapporto al tempo), come sempre è accaduto e accade quando si gode di un certo benessere economico rispetto agli anni precedenti. Tra l’altro le donne divennero più libere potendo partecipare anche ai banchetti, com’era già in uso presso gli Etruschi, più civili e all’avanguardia. Bastonarono politicamente, quindi, gli antichi e rozzi Quirites mettendoli nell’angolo. Pertanto, così come avviene da sempre ed anche oggi, la città cominciò a guerreggiare con i vicini e soprattutto ad allargare il proprio territorio (il pomerio) perché il commercio ha bisogno continuamente di nuovi spazi e quindi di nuovi mercati; ricorrendo anche alla violenza intesa non solo come violenza “armata” ma anche come sottomissione politica/economica. Oggi definita neo-colonialismo e/o post neo-colonialismo.
Il ritorno dei Quirites
Ma le antiche famiglie patrizie (Quirites) mordevano il freno e non appena ebbero l’occasione espulsero gli Etruschi dominanti e di conseguenza allontanarono dalle leve del potere di nuovo i Rumon ( chiamata per disprezzo, plebs: i più). Di nuovo un governo oggi diremmo di destra; di nuovo la “gravitas” delle antiche famiglie patrizie/Quirites; di nuovo le donne tenute, gelosamente, in casa.
Ma non potevano non lasciare delle cose oramai consolidate come ad esempio, tra le tante: la lingua (il latino) ed il nome della città (Roma).
Che le donne avessero perso un poco della “libertà etrusca”, viene dimostrato dall’episodio di Lucrezia la moglie di Collatino.
Narra, infatti, Tito Livio che alcuni giovani, tra cui Sesto Tarquinio figlio del re Tarquinio il Superbo, mentre l’esercito assediava Ardea, fecero la scommessa di vedere cosa facessero le loro donne in assenza dei mariti e fidanzati. Recatosi di nascosto a Roma videro che mentre le donne etrusche erano dedite ai divertimenti, le romane stavano in casa a filare con le ancelle. Indispettito Sesto Tarquinio fece violenza a Lucrezia, la quale, quando il marito tornò a casa, non sopportando il disonore, si uccise. Collatino fece vedere al popolo il corpo della moglie. Il popolò chiuse definitivamente le porte della città in faccia al re. Così la leggenda.
In realtà probabilmente ci furono eccidi e sommosse ma, così com’era successo in precedenza anche in Grecia, il potere del re venne piano piano “rosicchiato” dai nobili fino ad essere totalmente o parzialmente esautorato. In epoca storica, infatti, esisteva a Roma ancora un “rex sacrificulus o rex sacrorum”.
Tutto ciò è ammantato dalla leggenda di Porsenna, re di Chiusi che impose ai Romani clausole umilianti. Ma la saggezza politica accompagnata dalle battaglie vittoriose, da una parte allargò il territorio e con esso anche il commercio, dall’altra spinse i due ceti agli accordi che si concretizzarono principalmente nella lex Canuleia ( che consentiva i matrimoni tra patrizi e plebei), nella lex sacrata ( che istituiva i tribuni della plebe) e nella legge Licinae- Sextiae ( che prevedeva sostanzialmente la parità tra patrizi e plebei).
Ma non estinse l’odio verso gli Etruschi. Infatti, nonostante questi avessero dato tanto ai Romani (tra cui, in architettura, anche l’arco) ogni qualvolta i Romani vincitori venivano a contatto con le città etrusche, le radevano al suolo cercando di distruggere ogni loro vestigia. Per questo la civiltà etrusca, per noi è piuttosto lacunosa. Le donne, poi, ritenute di “facili costumi”, erano, con disprezzo, denominate “etrusche”. Il resto è storia risaputa, credo. In definitiva si venne a creare un certo equilibrio tra le classi sociali. Fino a che la sete di potere di alcuni supportata dal clientelismo non spianò la strada a guerre civili e feroci dittature fino a sfociare con Augusto nel Principato che poi si trasformò in Impero vero e proprio dal III secolo d.C. in poi con Settimio Severo.
Ma, forse, per i turisti e pellegrini che hanno affollato, affollano ed affolleranno Roma, a causa di questi eventi piuttosto complessi, è meglio che l’acronimo S.P.Q.R. si traduca per sempre e come sempre in: il Senato ed il popolo di Roma nella sua interezza e nella sua grandezza.
Almeno questa è l’opinione di…
Pasquale