di Tea Ranno
.
Nonna Dolcezza
Nonna Anna profumava di vaniglia, ma anche – a seconda dei giorni – di pandispagna, di mandorle tostate, torrone, gileppo, caramello o panicole.
Le panicole erano la specialità di suo fratello Giovanni, che aveva ereditato una delle pasticcerie di famiglia e ne portava avanti la tradizione; si trattava di grosse fette come di pandispagna, ma più alte e spugnose, con sopra una crosticina bianca di zucchero. Venivano regalate a pacchetti da mezzo chilo nelle visite di cortesia, perlopiù ai convalescenti che dovevano riprendersi da soggiorni più o meno lunghi in ospedale; ma non erano soltanto i biscotti dei malati – come qualcuno le chiamava -, erano buonissime comunque: farcite di Nutella o di marmellata, di crema pasticcera o al cioccolato, oppure, semplicemente, inzuppate nel caffellatte: inzuppavi, mordevi, chiudevi gli occhi e… godevi.
Zio Giovanni, nel suo laboratorio, preparava anche i pezzi duri: gelati informati in uno stampo a zuccotto con alternanza di gusti: perlopiù cioccolato e torrone, o gianduia e nocciola, ma anche zabaione e cassata siciliana (ricca di canditi a tocchetti, quest’ultima). Una volta indurito, il gelato veniva sformato, tagliato a spicchi, servito su piattini d’argento.
Col pezzo duro, ricordo, si chiudeva l’estate, gli ultimi venivano prodotti a ottobre, per la festa della Madonna del Rosario, poi se ne parlava a Pasqua – se non faceva troppo freddo -, o a maggio, per la festa del patrono, quando il paese si riempiva di pellegrini che venivano a piedi anche da molto lontano, per sciogliere i voti a quel Sebastiano bimartire così capace di miracoli.
Nonna Anna, era parte del laboratorio. «Non devi fare niente» le raccomandava suo fratello, «solo dare una guardata ai carusi».
Solo sovrintendere, dunque, controllare i lavoranti che montavano a neve gli albumi, o spumavano i tuorli con lo zucchero, o spicchiavano le mandorle dopo una breve immersione nell’acqua bollente. Ma la sovrintendenza non le apparteneva, e neppure l’arte del comando per cui, non appena lì, eccola a spicchiare mandorle, montare albumi, spumare tuorli, conversare con la pastafrolla, mescolare con devozione il torrone bianco, che poi, con due lunghe lame, compattava sul marmo, tagliava in piccoli rettangoli, ne adagiava ciascuno tra due ostie, l’avvolgeva in una stagnola e poi nella carta bianca con sopra scritto Dolceria Scamporrino.
Erano preziosi come lingotti quei pezzi di torrone: «Perché ci vuole una vita a farli, gioia mia» diceva lei.
I suoi vestiti odoravano dunque di torrone, le sue mani di vaniglia; la sua pelle sapeva di caramello, le sue carezze di pastafrolla, le sue parole di cannella anche quando raccontavano di Barbablù che mozzava la testa alle sue mogli, o di Betta Pilusa che si faceva guardiana di porci pur di sfuggire alle pretese d’amore d’un vecchio re; di anice, invece, profumavano le sue ninnenanne, perché le cantava sciogliendo in bocca una di quelle caramelle che tanto le piacevano.
In verità, le piacevano di più le caramelle al rabarbaro, amarissime, e non me ne spiegavo le ragioni.
Un giorno, però, che non ero alla portata dei suoi occhi, la sentii parlare con la za Concetta – una vecchia bisognosa, che non aveva nessuno che la campasse -, le diceva che la vita è amara.
«Donna Annettina» replicò quella, «giusto voi parlate di amarezze, che avete la casa piena di figli e nipoti, di ogni abbondanza e non vi manca niente. E io? Che dovrei dire io, che a me il Signore m’arrubbò il marito quand’era ancora un picciotto bello e forte, che pareva più forte della morte stessa, e invece ci venne un colpo e cadde senza manco il tempo di dire ahi?».
Lei annuì, sospirò: «Ragione avete. Ma voi vedete l’apparenza, e non li potete sapere i dolori appizzati nel cuore degli altri».
Se ne stavano tutte e due con le mani nell’acqua calda a sgusciare le mandorle; un fazzoletto in testa la za Concetta, una crocchia bianca mia nonna, vestita di nero la za Concetta, vestita di nero mia nonna, piccola e scura la za Concetta, candida di pelle e celeste di occhi mia nonna. Nel viso di entrambe, però, la stessa tristezza. Ma perché?
Intorno a noi, i carusi continuavano a sfaccendare, da una piccola radio veniva la voce di uno che esultava per quella cosa magnifica che l’uomo aveva messo i piedi sulla luna e che la luna sarebbe diventata presto una succursale della Terra: il primo passo era stato fatto, anzi, più di uno! Il resto sarebbe venuto prima di quanto pensassimo.
Uscii dal nascondiglio, giunsi alle loro spalle. Si voltarono e sorrisero, tutte e due, come toccate da una bacchetta magica che aveva cancellato la tristezza.
«Hai fame, gioia mia?», domandò nonna.
Andammo a casa.
Fu davanti a un uovo à la coque che le chiesi perché le piacessero tanto le caramelle amare. «Perché mi ricordano che la vita non è fatta solo di dolcezze» rispose.
«Ma noi viviamo in mezzo alla dolcezza.»
«Appunto.»
Come dirle che avevo sentito quel loro discorso? Che volevo sapere quale fosse il dolore che le pungeva il petto?
Mi prese in braccio.
Cominciò a cullarmi.
Cominciò a raccontare di una mamma e di una figlia piccola, di una mamma che diceva alla figlia che le sarebbe rimasta accanto sempre, anche quando non ci sarebbe stata più, sempre sempre, che non piangesse troppo: “La vita è così, non ci possiamo fare niente. Ma non si muore mai per davvero, mai, resta un filo che non si spezza”.
Ninnava e piangeva. Le sue lacrime erano salate, pure che tutto il resto di lei sapeva di vaniglia, di cannella, di pandispagna, gileppo, mandorle tostate…
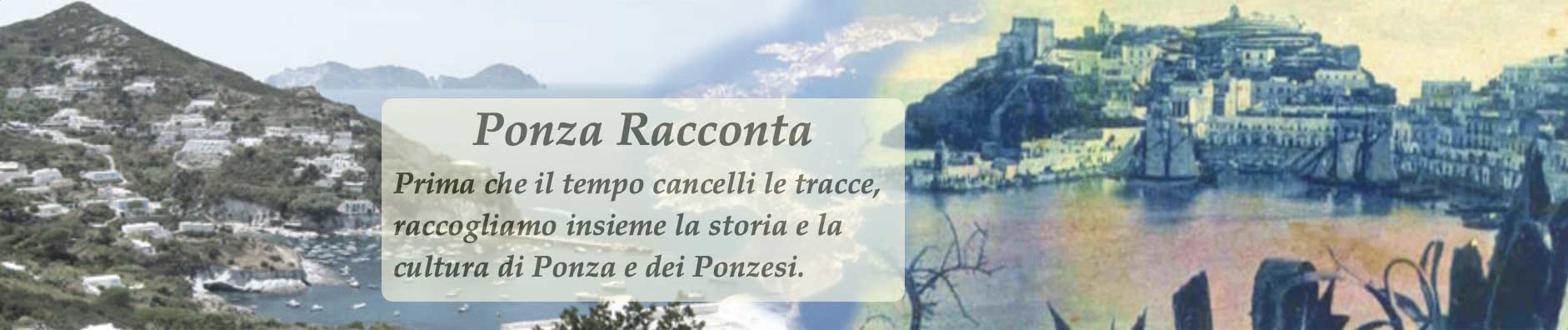








Fabio Lambertucci
25 Giugno 2024 at 12:30
Ringrazio la scrittrice Tea Ranno per il magnifico racconto. Ho capito perché mia nonna materna Elisabetta detta “Nonna Betta”, romagnola di Alfero (Forlì), regalava a noi nipoti (oltre me, mia sorella Paola e i cugini Marco e Paolo) le caramelle al rabarbaro, amare, che noi consideravamo quasi una punizione. È vero, la vita è amara. Per questo ci consoliamo con i dolci stupendi della Pasticceria siciliana. Grazie ancora,
Fabio Lambertucci.
Sandro Russo
25 Giugno 2024 at 20:02
Non conoscevo il termine “gileppo”. Sono andato a informarmi: è una glassa di zucchero non difficile da preparare (acqua, zucchero e qualche goccia di limone). Mia madre – di Ponza – lo chiamava “naspro”. Della parola che usava mia madre mi ha sempre colpito la discrepanza tra il sapore (dolcissimo) e il suono allegante (aspro) della parola