segnalato da Sandro Russo
.
Non manchiamo mai di segnalare le grandi opere di Renzo Piano in giro per il mondo, e la Repubblica le registra fedelmente – recentemente con Francesco Merlo aedo d’eccezione -, realizzazioni fatte in egual misura di ingegneria e poesia: tra le cose migliori del nostro tempo. A fondo pagina le schermate con gli articoli su Renzo Piano, sul sito.
***
PARLA RENZO PIANO
“Un rifugio tra gli alberi per i bambini”
di Francesco Merlo – Da la Repubblica del 16 giugno 2024
A Bologna il grande architetto presenta l’hospice sospeso nel verde che ha progettato per i malati pediatrici terminali: “La bellezza non basta, la morte non diventa migliore. Ma diventiamo migliori noi”
Altan ha decorato gli interni, Paolo Pejrone si è occupato delle piante. Tutto è nato grazie a Isabella Seràgnoli
Bologna – Se esistono le sette meraviglie del mondo, questa è l’ottava. Eppure è un edificio per bambini malati terminali, 8.350 metri quadri sospesi tra le robinie, «perché la sospensione – prova a spiegare Renzo Piano – è il poco che capisco di un bambino che arriva qui con una malattia inguaribile, sospeso appunto, come una lettera che non ha il destinatario, sul lembo del mondo». E allora «gli abbiamo costruito la casa sugli alberi», che finalmente dà una forma moderna alla pietà.
«Ko-mo-re-bi», sillaba Renzo Piano, «è una parola giapponese che non esiste in italiano e neppure in inglese, e da sola ha il significato di una frase: descrive la luce che filtra e che gocciola attraverso gli alberi. Non solo quel che vedi, ma anche la sensazione che provi quando ci passi in mezzo, in sospensione tra la luce e l’ombra che ti danzano attorno. Se i pittori e i fotografi riescono a catturare le sensazioni del komorebi, forse anche l’architettura può riuscirci e offrirle a un bambino malato». Per i giapponesi l’ombra è il riposo dello spirito. Per noi danteschi è l’anima in pena. Per Borges è il grigio della vecchiaia felice. Per un bimbo malato?
Piano mi invita a sdraiarmi supino sul letto di degenza. Di lato, attraverso la parete di vetro, vedo solo i rami e le foglie da cui gocciola la luce, e in alto c’è un buco sul soffitto dal quale guardo il cielo, e riesco anche a immaginarmi bambino perché vengo subito catturato dall’azzurro e poi dal bianco della nuvola.
Ma cosa penserà lui? Nessuna poesia è adatta a un bimbo malato terminale, né Pianto antico di Carducci, né Morto di Pascoli: «La notte c’era, non c’era il mattino. /Questo ti resterà. Dormi, bambino».
E Piano apre il letto a scomparsa: «Sono vecchio, e anche la mamma trentenne, o forse quarantenne, che gli dormirà accanto, per me, che ne ho 86, è comunque una bambina. E non è questione di miracoli e di pensieri romantici, non è nemmeno la bellezza dolente delle mamme che, come quella dei Promessi sposi, li portano in collo ma tutti “ben accomodati, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo”. Nel tempo sospeso, quando la malattia se l’è preso ma non gliel’ha ancora portato via, la mamma, chissà, forse prega o forse impreca o forse piange e lo accarezza, solo chi l’ha provata sa cos’è la sospensione».
Sicuramente la mamma e il papà avranno forte quel pensiero che Saba per discrezione mette tra parentesi: «(e non potere — come vorrei — dargli questa mia, della quale oggi ho vergogna, inutile salute)».
Una poesia tra parentesi è “la sospensione” che riassume e spiega “la scandalosa bellezza” che Piano insegue e che lo insegue. La sospensione è questa architettura di luce che finalmente ridisegna lo spazio della “morte confortata”.
E sono quattro i grandi vecchi d’Italia che hanno “creato” questo modello di futuro per chi non ha futuro.
Renzo Piano ha 86 anni. Il paesaggista Paolo Pejrone, che ha piantato 18.500 piantine, ne ha 83 e dice che «cresceranno nel gran disordine del giardinaccio» e quanto più esprimeranno la vita tanto più daranno un senso alla tragedia, come gli oleandri di Hiroshima, che tornarono a sbocciare già nel 1945. Il decoratore, il nostro Altan, ne ha appena 80, e ha liberato la Pimpa, il coniglietto, la farfalla e tutti i suoi animaletti, che dovunque ha disegnato bianchi, tranne nella mensa dove ha colorato un’arca di Noè: «Chissà se riusciranno a fare loro un po’ di compagnia, appena un po’ mi basterebbe».
E invece ne ha 79 Isabella Seràgnoli che è la finanziatrice, una donna con tanta delicatezza e con tanti soldi che, come vuole il vecchio aforisma di Margaret Thatcher, «hanno reso buono il Buon Samaritano più di quanto abbiano fatto le sue buone intenzioni».
Insieme, questi 4 nonni sembrano i 4 moschettieri al servizio dei bambini, nell’età che Alexandre Dumas non ha neppure provato a raccontare.
E, sorpresa, D’Artagnan è lei: «Ah, la Seràgnoli », dicono a Bologna cambiando l’intonazione del sospiro, a volte rassegnato e a volte ammirato. Tutti sanno che la signora usa i soldi per riparare i torti, proprio come d’Artagnan usava la spada sul ponte di Brixen, e come altri usano la penna. È la guasconeria bolognese che acchiappa il mondo, ma non con “l’allegra ragazzaglia” che urge e schiamazza in un fazzoletto di strade e viottoli. Nella Seràgnoli c’è invece l’Italia appartata del silenzio, quella per intenderci di Einaudi, Sciascia, Berlinguer e Mattarella. Ha fatto il Mast (1) che è un museo raffinato e bello quanto la Fondazione Prada (2), ma molto meno strombazzato, e poi tre centri per malati terminali adulti, e ha fatto tanto altro questa signora timidissima che risponde alla tua domanda solo se non gliela fai: «Avevo chiesto di provarci a due bravissime architette che si sono messe subito a disegnare, ma si sono arrese: “Non sappiamo farlo”».
E allora, circa sei anni fa, la signora è andata a Genova. Racconta Piano: «Mi ha detto solo 8 parole: “Renzo, disegneresti per me un hospice pediatrico a Bologna?”. E, poi, quando gli ho spiegato la casa sugli alberi, la sua risposta è stata ancora più breve, due parole: “Bella idea”».
Per quasi sei anni la Seràgnoli si è accanita sui dettagli, e ha mostrato la sua faccia nascosta con la famosa grinta di D’Artagnan. Come lui è generosa e come lui si accende: «Non c’è niente che non si possa fare e fare bene, se hai i mezzi».
L’hospice è costato meno di quanto costa in Italia un tipico ospedale che smette e ricomincia, cresce su stesso e resta incompiuto, ed è costato, a metro quadro, comprese le attrezzature, meno di un appartamento nuovo a Roma o a Milano, dove il prezzo è addirittura arrivato a ottomila euro a metro quadro. «L’energia, per più di tre quarti, è solare. È convenzionato con l’Emilia Romagna e dunque con il Sistema sanitario nazionale. Quando la Seràgnoli accettò la laurea honoris causa, illustrò nell’aula ‘Santa Lucia’ una tesi dal titolo “Uso del danaro privato in funzione pubblica”, che è il senso di questo hospice ed è anche la sua biografia di ricca filantropa sul modello puritano del mondo anglosassone. È infatti proprietaria della Coesia, il packaging industriale che impacchetta il mondo, ma poi finanzia questo capolavoro di natura e di umanità restaurate che ha il nome e il logo di Altan,
“L’arca sull’albero”, dove, dice Renzo Piano, «lo spazio è progettato anche per contestare il mondo dei malvagi. Proponiamo la solidarietà al posto delle facce orrende e tutte uguali della cattiveria che è rumorosa ma è minoranza. E non vorrei indulgere a sentimenti da libro Cuore o da Piccolo mondo antico, ma la maggioranza delle persone che incontro somigliano a Isabella, che, con il suo silenzio, arriva al cuore».
Qui la sospensione, pensate, arriva al cuore anche quando ci spostiamo: «Lo sai che io sono fissato con i ponti» mi dice Piano quando mi porta a vedere gli appartamenti destinati alle famiglie dei piccoli malati. E infatti ci si arriva attraverso due ponti di trenta metri coperti e anch’essi sospesi tra le foglie, affiancati da corridoi esterni con le pareti di lamelle di vetro che si aprono e si chiudono. «Lo so che potevamo fare una scatola, ma invece tra i malati e le famiglie abbiamo fatto i ponti che li uniscono e li dividono ». Ricordo che mi parve uno spettacolo guardarlo guardare le 18 scocche di nave che fanno volare le 19 pile di cemento a 50 metri di altezza mi disse – «sulla Genova di ferro e di aria» che è l’incipit di una poesia-capolavoro di Giorgio Caproni. Dice Piano: «Il vespro e la luce, che erano l’officina della poesia di Caproni, sono anche i materiali della mia architettura. Tra i poeti e i costruttori c’è una curiosità competitiva, una specie di simpatica gelosia reciproca». Gli ho visto guardare così anche il Beaubourg che, sebbene per vie diverse, somiglia anch’esso a una nave che vola.
E volano anche gli appartamenti che qui sono semplici e perfetti. Gli interni dell’hospice sono di legno, cedro americano, «che diventerà ancora più chiaro». E «come vedi non ci sono segni religiosi neppure nella saletta di meditazione, che non è laica, ma aconfessionale, compatibile dunque con tutte le religioni».
C’è il mezzanino per la riunione, la sala piscina per l’idroterapia. La mensa e la cucina sono affidate a Massimiliano Alaimo, un cinquantenne di due metri, con tre stelle Michelin nel suo “Le calandre” di Padova. In perenne lotta con gli additivi e con gli odori, chiede agli ingegneri dell’impresa Colombo di Lecco, che è la solita con la quale lavora Piano, la stessa che ha realizzato l’Auditorium a Roma, che «l’intero soffitto aspiri come fosse una grande cappa». Buonissime le polpettine al tartufo.
E poi, all’improvviso, non ci sono più alberi, non c’è più il legno chiaro, perché c’è la morgue, due camere mortuarie: «il faut qu’il soit triste» dice un amico di Piano che sinora era rimasto zitto. Gli chiedo in francese se è un medico. «Sì, sono un medico». Si chiama Jean Pierre Tarot, ha una affascinante aria bohémienne ed è stato il medico di Mitterrand, sino alla fine.
Nessuno aveva ancora trovato «la forma e il colore», direbbe Longhi, degli hospice pediatrici, ma da oggi, potete giurarci, tutti li faranno così, come a Bologna, «dove la morte – dice Piano – non diventa migliore, ma diventiamo migliori noi, anche se non basta la bellezza per leggerne il senso, per chiarirne il mistero».

Il ‘paginone’ dedicato, da la Repubblca del 16 giugno 2024 (cliccare per ingrandire)
Immagini (dall’articolo di Repubblica)
– Veduta aerea, la struttura sospesa tra gli alberi;
– Renzo Piano (a destra nella foto) seduto negli spazi verdi del nuovo hospice;
– un dettaglio dell’edificio
***
Due schermate della ricerca sul sito per “RENZO PIANO” (cliccare per ingrandire):

Note
(1) – Il museo MAST Castel Goffredo – museo della Città, si trova a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. E’ un museo di arte e storia del luogo, dai Longobardi ai giorni nostri (maggiori informazioni su Wikipedia)
(2) – La Fondazione Prada è un complesso di edifici museali situato a Milano, costituito da una galleria d’arte contemporanea permanente con opere di vari artisti tra cui Jeff Koons, Walter De Maria, Pino Pascali, Damien Hirst, Carsten Höller, e che ospita frequentemente molte esposizioni temporanee (fonte Wikipedia)
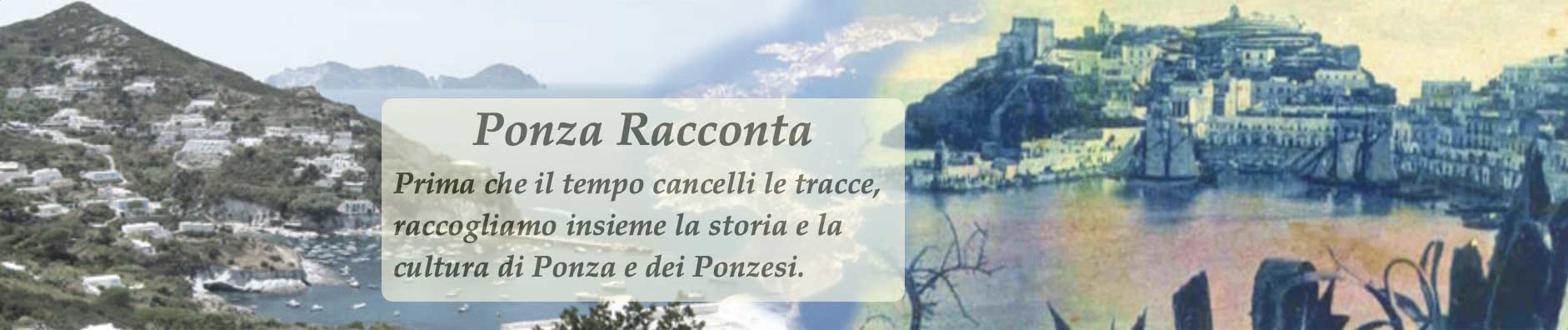










La Redazione
21 Giugno 2024 at 17:09
La Redazione propone due commenti all’articolo di Francesco Merlo su Renzo Piano
–
L’hospice, scandalosa bellezza
Caro Merlo, lei vuole attentare alla mia incolumità mentale. Alla mia anima di fruitore della bellezza, l’hospice pediatrico di Renzo Piano così bello, in un posto di dolore è …: non trovo le parole. Mi aiutano quelle di Piano: “La bellezza non basta, la morte non diventa migliore. Ma diventiamo migliori noi”. Gli occhi si velano di commozione. Dopo aver visto un falso spudorato in Puglia e l’assalto al “provocatore” in Parlamento, ecco la “bellezza al potere” seppur in un luogo catartico, costruito da Renzo Piano, insieme ad altri intellettuali e una signora che parla poco e agisce molto. Un luogo sospeso tra gli alberi che rappresentano la vita. È come se quel luogo accarezzasse le mani di un bambino, le sue guance, la sua anima. Ho un nipotino che è recidivo e lotta, con l’aiuto della medicina, per avere un futuro. Mi riesce impossibile capire perché un bambino si ammala così pericolosamente. Non lo trovo giusto.
Piero Orrù
Risponde Merlo
Non c’è famiglia che non sia stata colpita dal cancro che è la minaccia che arreda la mente di tutti, il nodo grosso e la malattia d’epoca. E tuttavia, grazie alla scienza, sono sempre di più gli adulti e i bambini che ce la fanno. Non superstiti, sopravvissuti o scampati, ma guariti che riacquistano il futuro, il diritto di morire fra cento anni di cause naturali. Dimentichi l’hospice di Bologna, con la scandalosa bellezza che ho raccontato, e non smetta di lottare per il nipotino.
–
Caro Merlo, sono una cittadina bolognese che ha da sempre ammirato l’impegno straordinario di Isabella Seràgnoli, e l’hospice pediatrico, che lei ci ha raccontato, mi ha commosso. Non posso che condividere le sue parole e sono orgogliosa di vivere in una città come Bologna dove succedono ancora i miracoli!
Marina Senin – Bologna
Risponde Merlo
Bologna, come canta De Gregori, non crede nei miracoli, ma li sa fare.
[Da la Repubblica, rispettivamente del 18 giugno (P. Orrù) e del 20 giugno (M. Senin) dalla rubrica “Posta e Risposta” di Francesco Merlo
Sandro Russo
27 Giugno 2024 at 20:59
Da “Posta e risposta” di Francesco Merlo. da la Repubblica del 27 giugno 2024
–
Caro Merlo, “komorebi” è la cosa più bella che ho letto ultimamente. Grazie a Renzo Piano e agli altri ultraottantenni che hanno messo in piedi l’hospice pediatrico di Bologna. Il miracolo non è la guarigione, ma il tempo donato e vissuto tra luci e ombre. Difficile dire se siano più importanti le une o le altre.
Luca Cardinalini – Marsciano (Perugia)
Risponde Merlo
“Ko-mo-re-bi”, ha spiegato Renzo Piano, “è una parola giapponese che non esiste in italiano e neppure in inglese, e da sola ha il significato di una frase: descrive la luce che filtra e gocciola dagli alberi. Non solo quel che vedi, ma anche la sensazione che provi quando ci passi in mezzo, in sospensione tra la luce e l’ombra che ti danzano attorno. Se i pittori e i fotografi riescono a catturare le sensazioni del komorebi, forse anche l’architettura può riuscirci e offrile a un bambino malato”.
Non parlo il giapponese ma a Hiroshima scoprii un’altra parola, Hibakusha, che si traduce con la seguente lunghissima frase del premio Nobel Kenzaburō Ōe: “Hibakusha sono coloro che non morirono, ma furono esposti alle conseguenze della bomba, non necessariamente fisiche, e non si suicidarono nonostante avessero tutte le ragioni per farlo”.