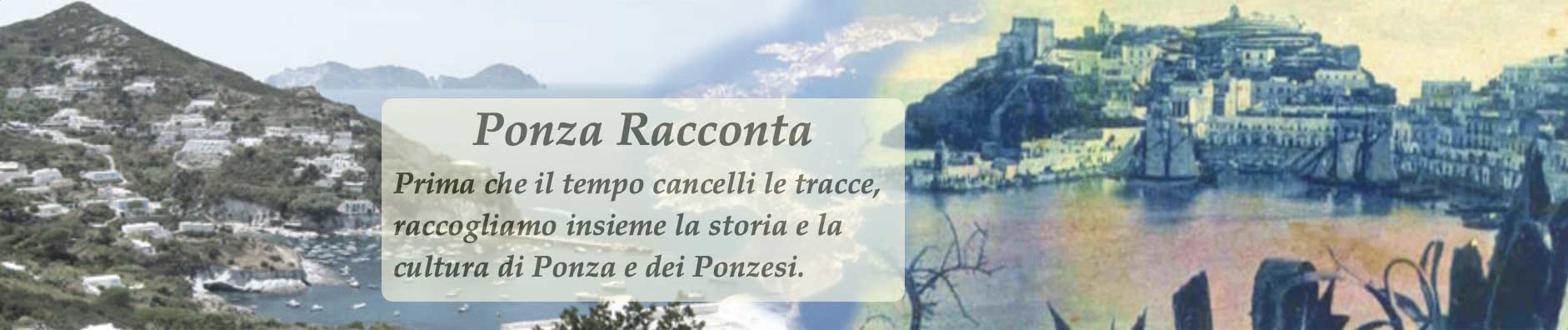segnalato da Sandro Russo
.
È morta a 93 anni Alice Ann Munro, all’anagrafe Alice Ann Laidlaw [Wingham (Ontario, Canada), 10 luglio 1931 – Port Hope, 13 maggio 2024] , scrittrice canadese, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2013.
Ne abbiamo scritto in quell’occasione e in molte altre, sul sito (una schermata dell’indice per la voce Alice Munro, a fondo pagina):
Ad Alice Munro il Premio Nobel per la letteratura
di Sandro Russo – Pubblicato il 10 ottobre 2013
 Ad Alice Munro, la bella signora canadese della foto, classe 1931, è stato assegnato oggi il premio Nobel per la Letteratura
Ad Alice Munro, la bella signora canadese della foto, classe 1931, è stato assegnato oggi il premio Nobel per la Letteratura
La rievochiamo qui attraverso un bell’articolo su la Repubblica di Antonio Monda, cultore di cinema e letteratura americana, che di recente abbiamo letto su queste pagine, in occasione della scomparsa di Paul Auster.
Alice Munro è morta. La scrittrice premio Nobel maestra delle “short stories”
di Antonio Monda – – Da la Repubblica del 14 maggio 2024
Nata nell’Ontario, visse l’adolescenza in una fattoria. Per lei scrivere era “un meraviglioso sbalordimento”. Con il primo marito James aprì in Canada una famosa libreria ancora in attività
“Voglio che la scrittura mostri come sono complicate le cose e sorprendenti. Voglio emozionare i lettori, ma senza trucchi. Voglio che pensino sì, quella è vita. Perché è la reazione che ho io di fronte alla scrittura che ammiro di più. Una sorta di meraviglioso sbalordimento.” Scrivere, per Alice Munro, era il suo modo più intimo di interpretare la vita e condividere l’incanto di fronte alla meraviglia dell’esistenza, ma la sincerità rappresentava un’urgenza e un codice morale da tenere sempre a mente di fronte alla complessità dell’esistenza: sia nell’agire quotidiano che nella scrittura riteneva imperativo agire “senza trucchi.”
Non esisteva nulla per lei più importante della trasparenza, e rifiutava sia il cerebralismo che la ricerca della frase troppo lavorata e a effetto: la “bella scrittura” che definiva letteraria” le appariva l’opposto della verità. Era nata 92 anni fa con il nome di Alice Ann Waidlaw a Wingham, nell’Ontario, dove crebbe nella fattoria del padre Robert, un agricoltore che allevò prima visoni e poi tacchini, convinto che si trattasse di un’attività più redditizia. Il tentativo si rivelò fallimentare, ma nonostante una improvvisa situazione di stenti, Alice Munro dichiarò di essergli grato per averle insegnato la capacità reinventarsi. Fu la madre Anne, insegnante di liceo, a farle conoscere gli scrittori che la segnarono in maniera indelebile, a cominciare da Anton Cechov.
A diciassette anni vinse una borsa di studio all’University of Western Ontario e l’entusiasmo di allontanarsi dalla vita rurale le diede la forza di mantenersi con meno di un dollaro al giorno. Lavorò come cameriera e assistente bibliotecaria, e spesso, per racimolare qualche denaro in più si prestò a raccogliere il tabacco e anche a donare il sangue. È nella biblioteca dell’università che incontrò James Munro, un giovane che lavorava in un grande magazzino per pagarsi gli studi di giurisprudenza, il quale rimase molto colpito dalle sue lettere e la incoraggiò a scrivere. A differenza di Alice, proveniva da un ambiente benestante, nel quale l’etica del lavoro non prevedeva alcun aiuto economico da parte della famiglia. In un primo momento ammirò il rigore di quel mondo, ma fu molto ferita quando i genitori di James si opposero con ogni mezzo al loro matrimonio. Si trasferì con James a Vancouver e poi a Victoria, dove aprirono la Munro’s books, una libreria che è tuttora un punto di riferimento culturale della città.
Il loro amore generò cinque figlie, una delle quali morì quando aveva solo un giorno, un dolore che l’ha accompagnata per tutta la vita. Ha sempre ricordato quegli anni con grande affetto, e sebbene divorziò da James nel 1972, continuò a mantenerne il cognome anche dopo aver sposato Gerard Fremlin, un cartografo con cui tornò a vivere nello stato dell’Ontario. Si mise in luce a livello nazionale nel 1959 con il racconto La pace di Utrecht nel quale affrontò il tema dell’invalidità della madre e poi della sua morte. La critica canadese esaltò la scrittura limpida e sincera di un’autrice che sin d’allora preferiva apparire e parlare poco: anche le interviste le apparivano una forma di artificio e vanità.
La fama cominciò ad arriderle dieci anni dopo, grazie alla raccolta La danza delle ombre felici, con il quale vinse il Governor General’s Award, il più prestigioso premio canadese che in seguito le verrà attribuito altre due volte. In questa prima raccolta, come nel successivo Vita di ragazze e donne consolidò uno stile potente e inconfondibile, costruito su continui spostamenti di tempo nei quali il linguaggio predilige la rivelazione sulla dimostrazione o, peggio, l’esibizione. Sin da allora instaurò un patto di onestà intellettuale con il lettore, attraverso storie segnate da un’estrema raffinatezza psicologica e una struttura narrativa dove apparentemente avviene poco, lasciando intuire parallelamente rivoluzioni e tormenti interiori.
I racconti parlano del momento della maturazione di giovani ragazze, della solitudine di donne mature, di ambienti opprimenti e bigotti e del mondo rurale che si era illusa di abbandonare per sempre. È il periodo in cui Cynthia Ozick la definì “la nostra Cechov”, e i suoi racconti iniziarono a essere pubblicati sulle riviste più prestigiose, a cominciare dal Paris Review e il New Yorker. Nelle sue storie, che rielabora continuamente, ripubblicandole a volte a distanza di anni, appare ossessionata dallo scorrere implacabile del tempo e si interroga su cosa spinga la gente comune in ogni scelta quotidiana. È una domanda alla quale non trova mai una risposta definitiva, ed è questo il motivo per cui ha rielaborato continuamente quanto ha scritto, non considerandosi depositaria di verità, ma semplice interprete della impotenza umana: del racconto Powers, esistono otto versioni differenti.
Oltre che un dovere, la scrittura rappresentava quindi una domanda posta continuamente, che tuttavia non generava sgomento perché la prima emozione continuava a essere quella di stupore nei confronti della sorpresa stessa di essere al mondo. Questo ovviamente non le impediva di avere convinzioni potenti, come quello di “uccidere”, secondo l’insegnamento di Virginia Woolf, “l’angelo della casa, l’ombra della donna ideale e vittoriana, sacrificata, buona e pura.” Cominciò allora a diventare un punto di riferimento per autori quali Jonathan Franzen, che in un celebre saggio la celebrò come la più grande scrittrice vivente prima che le venisse conferito il Nobel nel 2013.
Parallelamente sono cominciati, con risultati alterni, anche gli adattamenti cinematografici dei suoi testi, tra i quali i più validi sono Lontano da lei, diretto da Sarah Polley con Julie Christie e Julieta, che Pedro Almodovar ha realizzando prendendo spunto da tre diversi racconti. Sin dagli esordi questa “maestra del racconto contemporaneo”, così dice la motivazione del Nobel, è stata paragonata a Flannery O’Connor: l’Ontario della Munro interagisce con i suoi personaggi in maniera simile al sud degli Stati Uniti della scrittrice americana, e se è vero che in quest’ultima la dimensione religiosa ha un ruolo più importante, è altrettanto vero che entrambe risolvono le loro storie con improvvise e sorprendenti epifanie.
Sono spesso i dettagli minimi a rivelare e rivoluzionare, lasciando ai protagonisti e ai lettori la constatazione della fragilità di ogni attività e sentimento. Ma nel momento in cui gli ideali, i sogni di successo e persino l’amore si rivelano in tutta loro fallacia rimane l’incanto per il privilegio e la meraviglia di essere al mondo.
[Di Antonio Monda, Da la Repubblica del 14 maggio 2024]
Sul sito: