di Rosanna Conte
.
Gino, l’anarchico libero pensatore, geniale strambo a cui Franco De Luca affida la riflessione sugli articoli impegnati politicamente e socialmente nella sua epicrisi domenicale (qui), afferma che la storia insegna e, distinguendo le cause dagli effetti, attribuisce meriti e colpe.
Caro Gino, non si direbbe che la storia insegni, come invece potrebbe essere, viste le stragi e le guerre che continuano da millenni. La storia ricostruisce eventi e contesti seguendo i connettivi logici del “perché” e del “poiché” che non possono essere invertiti senza commettere gravi errori di logica.
È poi, nella libertà di chi guarda ai suoi esiti dare giudizi che indubbiamente sono legati ai propri valori di riferimento. E su questo ci si può confrontare e dialogare chiarendo i principi in base ai quali il proprio giudizio è diverso da quello altrui. Quando c’è scontro significa che quello che è emerso dalla storia non è stato ancora metabolizzato e che i valori sconfitti aspirano ad una rivincita È su questo che ci si “divide”. La storia in questo contesto non ha colpe perché le fratture già ci sono, anzi è tirata a strattoni da chi vorrebbe piegare gli esiti dalla propria parte ed è mutilata e deformata
 .
.
Purtroppo nel tempo della semplificazione a tutti i costi “il racconto” che passa è quello che viene compreso subito attraverso le emozioni invece che secondo logica. Insomma chi la racconta meglio solleticando astio, rancori vecchi e nuovi può far passare più facilmente la sua interpretazione.
La pacificazione si potrebbe avere solo quando ci fossero valori fondamentali condivisi e in Italia non pare che sia così.
Chi oggi applaude a Mussolini come fa a condividere i valori della democrazia e della libertà visto che se avesso vinto Mussolini noi oggi non avremmo né l’una né l’altra? Probabilmente per molti italiani la libertà e la democrazia passate attraverso il consumismo, le crisi economiche, la globalizzazione e un discorso pubblico centrato sempre più sul privato, hanno perso la connotazione di alti valori fondativi del nostro vivere civile. È questo quello che nei fatti divide.
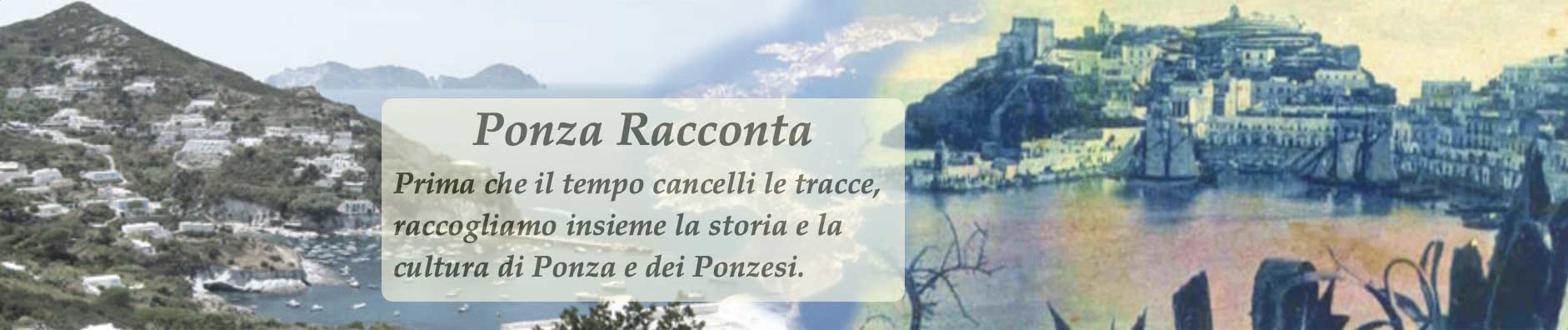






Francesco De Luca
14 Febbraio 2023 at 19:45
Non sono l’avvocato d’ufficio di Gino, ma mi sento chiamato in causa e chiarisco il mio pensiero. Il mio, non quello di Gino.
Orbene, la Storia (o storiografia) non giudica, comprende. Ovvero la Storia non opera secondo le coordinate: chi ha ragione e chi ha colpa.
La storiografia che giudica e che divide chi ha colpe da chi ha meriti mi sembra ormai retaggio del passato.
Essa studia, a mio vedere, ed individua le ragioni che hanno determinato gli eventi. Senza portarsi a giudicare moralmente i fatti. Il giudizio morale lo dà chi legge e si schiera, in base a criteri non di natura razionale. Non così la storiografia che presenta i fatti, ne individua i moventi, ne evidenzia le conseguenze.
I fatti esecrandi che la storia presenta sono palesati, non minimizzati né sottaciuti.
Lo sterminio degli ebrei non è svilito nelle ‘ragioni storiche’ che lo ‘storicismo’ (ovvero il tentativo di giustificare ogni evento storico) presentava come innervato nei fatti e perciò non giudicabile. No, lo storicismo va combattuto come falsario.
La Storia studia i fatti, ne evidenzia le implicazioni, ne esplicita le motivazioni e palesa ciò da cui si è partiti e ciò a cui si è pervenuti. Nessuna condanna morale. Questa la partorisce, se lo fa, il lettore non lo storiografo.
L’atteggiamento maturo cui è pervenuta la storiografia attuale è questa.
Che ci siano (o siano stati) obbrobri nei fatti storici non è taciuto. Che ci siano (o ci siano state) cadute aberranti nei comportamenti dei singoli e degli Stati nazionali, di ‘partigianerie’ e di nazionalismi, tutto questo lo dedurrà lo studioso, il lettore, nell’intimo della sua personale morale, e lo biasimerà.
Non c’è una morale nella Storia. Non ci deve essere. Lo stesso ‘olocausto’ deve essere visionato nei suoi fattori generativi e in quelli degenerativi. Al lettore la sentenza morale (estesa alla generazione e perfino al giudizio del secolo).
Cosa insegna allora la Storia? Insegna a vedere, dietro ad ogni comportamento, le forze che animano, quelle che frenano, quelle che agevolano e quelle che produrranno malessere e benefici.
La Storia non persegue l’insegnamento come discernimento morale, no, la Storia evidenzia e presenta i fattori da essere compresi. Solamente compresi e non giudicati.
Il giudizio morale lo darà il singolo o una comunità sociale, e lo darà in forza di un sentimento esteso e condiviso, non di chiare evidenze razionali. Essendo queste prive di forza morale (tanto è vero che nei secoli il giudizio morale su fatti storici è mutato, addirittura stravolto).
Per cui noi condanniamo il Fascismo perché imponeva il suo discernimento sui singoli senza averne la rappresentanza. I crimini che ha commesso li disprezziamo. Anche quelli contro la popolazione dalmata. Allo stesso modo disprezziamo i crimini degli iugoslavi su mandato di Tito.
Il disprezzo dei fatti avvenuti nel passato, oggi, deve alimentare la comprensione, non l’odio; la differenza non la divisione.