di Patrizia Maccotta
.
Emile Zola mi ha salvata! Non è un verbo troppo importante? No. Anzi. Se non fosse stato per lo scrittore francese, non avrei mai superato l’esame di letteratura italiana che avevo lasciato per ultimo nel mio corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne; lingua straniera era per me l’italiano e mi era, purtroppo, quasi sconosciuta la letteratura di quello che era, comunque, il mio paese.
Ma nel 1972, il professor Alberto Asor Rosa, notoriamente di sinistra, nominato ordinario di Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma, scelse, in modo innovativo, quasi rivoluzionario, come unica materia per l’orale del suo esame un corso monografico su György Lukács, filosofo ungherese, e sui suoi “Saggi sul realismo”. Grazie a lui ero alla pari con gli altri studenti.
György Lukács mi piacque subito. La prima parte della sua opera mi portava, d’altronde, su un terreno conosciuto, in compagnia di Balzac e di Zola. Povero Lukács! Come prevedere allora che il Primo ministro Orban avrebbe fatto rimuovere la sua statua (lui che era sempre stato contrario al controllo della politica sull’arte!) dal parco di Szent Istvàn di Budapest? Per la dissertazione scritta, il prof. Asor Rosa scelse come tema un confronto tra il “Naturalisme” ed il Verismo! Così, Capuana, Verga e Zola mi guidarono verso il traguardo della mia laurea.
Ho comunque sempre molto amato Zola (Parigi, 1840 – 1902): per il suo sguardo lucido sul nascente mondo della classe operaia, per il suo rigore scientifico, la sua onestà nel documentare le sue opere, per il suo “engagement” e la sua generosità nel difendere l’ufficiale Alfred Dreyfus accusato ingiustamente, soprattutto per ragioni antisemitiche, alla fine del 1894.
 J’accuse. Il celebre articolo di Zola su L’Aurore, del 13 gennaio 1898
J’accuse. Il celebre articolo di Zola su L’Aurore, del 13 gennaio 1898
Le pagine dei suoi romanzi, che ci descrivono il lavoro dei minatori del nord della Francia, le condizioni degli operai nelle grandi città e dei contadini nelle campagne, il mondo della prostituzione, dei nascenti grandi magazzini, dell’arte, della borghesia e della finanza, ci danno un quadro completo della società francese sotto il Secondo Impero.
Quello che ignoravo allora era che Zola avesse scritto un romanzo intitolato “Roma”, il secondo di un ciclo, “Les trois villes”, che comprendeva anche Lourdes e Parigi.
Fedele al suo metodo scientifico, Zola decise di recarsi sul posto per studiare dal vivo Roma e la sua società. Partì, pertanto, non come turista o come studioso della storia e dell’arte, ma come osservatore, come sociologo.
Annotò tutte le sue impressioni su quattrocento fogli che furono, in seguito, raccolti in un “Journal” intitolato “Mes voyages. Rome”. Amante della fotografia ed amico di Nadar, fotografò senza tregua le vie e le piazze della giovane capitale d’Italia: i suoi scatti accompagnarono le sue parole.
 Una strada di Roma fotografata da Zola
Una strada di Roma fotografata da Zola
Bisogna immaginare l’arrivo dello scrittore in quel 31 ottobre del 1894, un mercoledì, in una stazione Termini inaugurata circa una ventina di anni prima. La tettoia di Termini era metallica ed univa due corpi che avanzavano verso le terme di Diocleziano duecento metri in più rispetto al corpo di oggi.
 La stazione Termini a fine Ottocento
La stazione Termini a fine Ottocento
Il conte Luigi Primoli, formatosi a Parigi ed amico di tanti artisti francesi come Degas, Dumas, Maupassant e i fratelli Goncourt, anch’esso fotografo appassionato, lo ritrae, alle sette del mattino, davanti alla carrozza, appena sceso, insieme all’imponente Alexandrine, sua moglie. La coppia aveva lasciato a Parigi il “petit ménage” dello scrittore, Jeanne Rozerot ed i loro due figli. Ménage che Alexandrine seppe accettare, alla fine, con dignità anche se con sofferenza.
Oltre a Luigi Primoli, danno il benvenuto alla coppia Attilio Luzzatto, direttore di La Tribuna, il conte Bertolelli, i corrispondenti dell’agenzia Havas, del Matin, del Figaro e del New York Herald.
 I coniugi Zola al loro arrivo a Roma. Foto di Luigi Primoli
I coniugi Zola al loro arrivo a Roma. Foto di Luigi Primoli
 Attilio Luzzatto e il conte Bertolelli che accolsero lo scrittore a Termini
Attilio Luzzatto e il conte Bertolelli che accolsero lo scrittore a Termini
Zola ed Alexandrine sono accompagnati, in seguito, al Grand Hotel, inaugurato lì vicino solo dieci mesi prima e dotato di illuminazione elettrica, dove li attende un intimidito Luigi Capuana.
Povero Capuana che aveva diffuso l’opera di Zola e gli aveva dedicato il suo “Giacinta”! Zola lo cita poco nel suo diario e solo alla fine.
Annota il 2 dicembre: “Stamattina ho visto Capuana che mi ha fatto una fotografia. Abita a via Arcione 88, al terzo piano, in una vecchia casa romana”.
Aggiunge poi: “Sono andato con Capuana chiacchierando al Pincio”.
Il 3 dicembre invece, dopo una serata passata al teatro Valle, Zola lascia questo commento: “L’indomani Capuana mi ha detto che tutte le città d’Italia producono artisti da vent’anni mentre Roma è sterile. (…) Una popolazione da museo che vive solo di turismo”.
Parole poco lusinghiere, come lo sono d’altronde le sue prime impressioni, il 31 ottobre, nel giungere a Roma: “Sono arrivato questa mattina alle sette, dopo avere attraversato la campagna romana all’alba. Una grande desolazione (…) terreni tristi dall’erba rada”.
Zola aveva lasciato Parigi alla quale, anni prima, il barone Haussmann, quando era prefetto del dipartimento della Senna, dal 1853 al 1870, aveva regalato, a dire il vero sventrandola, un nuovo volto. Aveva ancora sotto i suoi passi i grandi boulevard ed i grandi assi nord-sud. La tour Eiffel, inaugurata cinque anni prima per celebrare, all’esposizione universale di Parigi, il centenario della rivoluzione francese, svettava nel panorama di una città che contava 2.000.000 di abitanti. Il suo treno era sicuramente partito dalla già ampliata e modernizzata Gare de Lyon che aveva visto il suo primo binario nel lontano 1853.
Si trova ora nella giovanissima capitale di un giovanissimo stato, una città di 400.000 abitanti che sta iniziando a cambiare pelle. Piazza Venezia è ancora una piazza chiusa e San Pietro ed i Fori sono circondati da vecchie case. Esiste una sola grande via, via Nazionale, che deve il suo recente tracciato a monsignor Francesco Saverio de Mérode, un ecclesiastico di origine belga, fautore della prima fase di urbanizzazione di Roma, un po’ speculatore per di più, non a un prefetto!
Lo accompagna nella scoperta della città il personaggio principale del romanzo Rome, padre Pierre Froment, autore anche lui di un libro, “La Nouvelle Rome” – il cui titolo la dice lunga sulle aspettative di Zola – che viene a difendere perché messo all’indice.
Lo scrittore non è un appassionato di archeologia. Poco tempo e poche righe sono dedicate alla visita delle antichità. Nel diario, il 2 novembre, Zola annota: “Tutta la giornata passata tra le rovine, un’indigestione di rovine, più che sufficiente per evocare la grandezza romana” (!). Precisa in seguito: “Ho voglia di far fare a Pierre quello che ho fatto, la visita delle rovine in una giornata”. Tutta la storia antica di Roma in un solo giorno insomma!
È “La nouvelle Rome” che lo attira in fondo. Il suo personaggio avrebbe voluto la deviazione del Tevere; approva lo sventramento delle vecchie case per fare spazio al corso Vittorio; approva la demolizione del Ghetto. Vorrebbe eliminare tutte le vie tortuose e maleodoranti. Il senso di strettezza pervade tutte le sue osservazioni di Zola: “Trastevere, vie strette, miserabili, puzzolenti”. Il Foro è “piccolo e grigio”; il Corso gli dà “una sensazione di strettezza”.
Il Pincio, anch’esso, è considerato stretto! “Tutto è stretto e meschino, ma il panorama è meraviglioso”. Almeno il panorama è salvo!
Villa Borghese è considerata “non grande” (viene forse paragonata, in modo errato, al Bois de Boulogne che non è una Villa), il suo boschetto è definito “mal tenuto”. Neppure Villa Medici, Accademia di Francia, trova la sua completa approvazione: “La verità è che la villa è deliziosa sotto questo bel cielo, con lo splendido orizzonte di Roma, ma bisogna avere un’anima sognatrice e contemplativa. Qualunque uomo d’azione e di lotta deve morire di noia”. Addirittura!
Passeggiando per via Giulia, Zola decide di avere trovato il luogo dove fare vivere Pierre. Ma il suo personaggio, come lui, è interessato al nuovo quartiere a scacchiera Prati di Castello. Approva la lottizzazione della Villa Ludovisi per la costruzione di un quartiere aperto e di aspetto moderno.
Si rammarica che Roma non sia un “centro”: ha una sola stazione ferroviaria degna di questo nome mentre Parigi, oltre alla Gare de Lyon da dove è sicuramente partito, possiede la Gare Saint Lazare, evocata in un bel dipinto da Manet nel 1873, la Gare du Nord inaugurata nel 1846, ampliata nel 1860 e modernizzata nel 1889 e la Gare Montparnasse costruita nel 1840.
Nella città, già da allora, i trasporti erano carenti. C’erano poche linee di tramway a cavallo e la prima linea elettrica sarà inaugurata un anno dopo il soggiorno di Zola, nel 1895. Pierre ed il suo autore auspicano la costruzione di una metropolitana, realizzazione che era già in cantiere nella capitale francese e che sarà inaugurata nel 1900.
Una bella mostra che si è svolta nel 2009 presso il Museo Ferroviario di Roma, intitolata “A la gare comme à la gare! Signori, in carrozza!”, ci ha illustrato le differenti condizioni dei trasporti a Parigi e a Roma tra Ottocento e Novecento.
 I900. Inaugurazione della metropolitana di Parigi
I900. Inaugurazione della metropolitana di Parigi
Sempre per la stesura del suo romanzo, Zola frequenta e studia la società romana. E’ ricevuto in vari salotti aristocratici, spesso accompagnato da un giovane Ugo Ojetti che prende appunti per lui: i salotti delle famiglie Odescalchi, Locatelli, Santacroce. Frequenta, ovviamente, l’Ambasciatore francese in Italia, Monsieur Billot. Fa amicizia con il Conte Primoli. I nobili romani ed i loro palazzi, con numerosi piani in affitto, gli sembrano decadenti. La borghesia è, secondo lui, ancora inesistente ed il popolo infantile. Annota così nel suo giornale: “C’è dunque un’aristocrazia morente, una borghesia che non esiste ancora e che dà la caccia ai posti (…) e un popolo tornato bambino, povero, sporco, ignorante e ozioso”. Un giudizio molto duro.
Zola è ricevuto, alla fine del suo soggiorno dal re Umberto I, che viene definito “un brav’uomo, dall’aria semplice e buona” (sic!) e , con la moglie, dalla regina che fa accomodare Alexandrine vicino a lei sul canapé e che viene definita “intelligentissima”. Non è invece ricevuto, come forse si aspettava, dal papa Leone XIII, sicuramente per i contenuti della sua opera.
Il 5 dicembre lo scrittore lascia la città chiedendosi “se Roma diventerà mai una capitale moderna”. Il suo giudizio è forse ancora, in parte – cerco ora di attenuare il mio! – valido oggi.
Ma io preferisco ricordare, tra i suoi commenti, quelli entusiastici, sui panorami e sui cieli di Roma al tramonto; preferisco ricordare Alexandrine, così felice nel ricevere ogni mattina un bouquet di fiori freschi, così innamorata della “nouvelle Rome” da mettersi ad imparare l’italiano per ritornarvi ogni anno ad incontrare quelli che divennero i suoi “amici italiani”, il Conte Primoli e Attilio Luzzatto, e a passeggiare nei giardini, da lei definiti “incantati” di Villa Borghese e di Villa Medici.
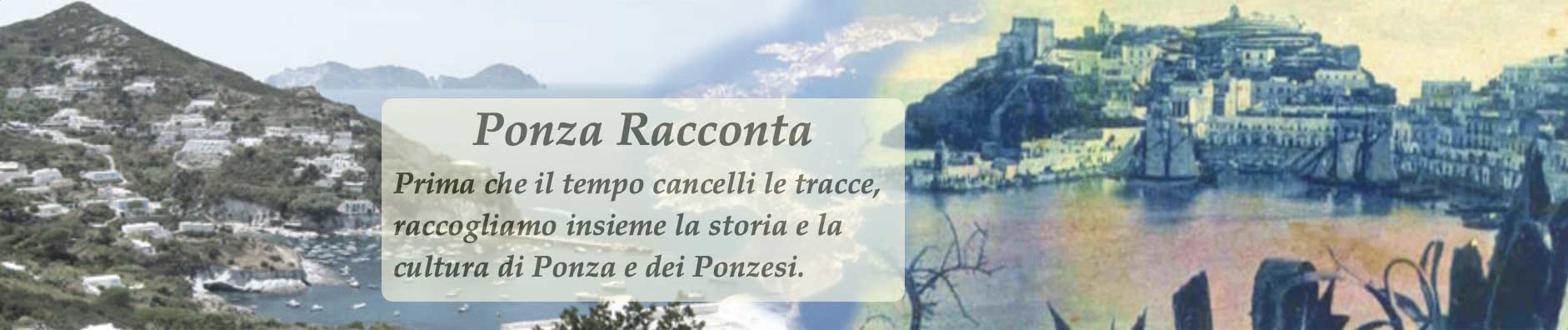









Nazzareno Tomassini
22 Aprile 2021 at 19:25
Ah, questi francesi, da sempre così presuntuosi! Ma che si aspettava Zola di trovare a Roma?
Evidentemente conosceva poco la storia d’Italia. Eppure sarebbe bastato che guardasse le foto che proprio alla fine del XIX secolo avevano fatto i fratelli Alinari. Dentro il Colosseo la gente ci abitava e fra le rovine dei fori imperiali ci pascolavano le pecore. Il Pincio era ancora una piccola terrazza sterrata e la basilica di San Pietro era soffocata dal Borgo Pio, distrutto in parte solo negli anni ’50 per far posto a via della Conciliazione. E ancora oggi, passeggiando lungo la via dei Fori Imperiali, se si guarda a sinistra verso le Terme di Diocleziano, le rovine che si vedono sono quelle della Roma medievale e allora possiamo capire ancora meglio quello che poteva aver visto Zola. Senza dimenticare che anche la via dei Fori venne realizzata tra il 1924 e il 1932 ai tempi di Mussolini, così come l’EUR e il Foro Italico, tutti quartieri nuovi, pensati per far diventare Roma una capitale veramente “moderna”.
Ornella Cacciò
28 Aprile 2021 at 12:49
Ohi ohi ohi, turista? Non direi ‘turista’, piuttosto severo analizzatore di una società. Sicuramente Roma a quel tempo era una piccola città provinciale e sporca, con un popolazione sciatta e cialtrona abituata ad essere sottomessa al papa-re. Ma il tono e il giudizio di Zola sono forse un po’ troppo sprezzanti, sembra quasi non voglia accettare che non tutto è moderno e luminoso e non tutto corrisponde ai suoi ideali di progresso sociale. Mi consola pensare che anche Parigi, quando adolescente vi si recò per la prima volta, lo deluse profondamente trovandola piccola e poco seducente. Per Roma, però, sembra esserci un rifiuto preconcetto:… come si può trovare Villa Medici ‘noiosa’, non vedere la complessità ed il fascino delle memorie storiche!
Ma ho letto con grande piacere questo reportage della visita dello scrittore che mette in evidenza un periodo storico ed un personaggio che credevo di conoscere piuttosto bene.
Mi ha fatto mettere a fuoco come fosse diversa la città che amo e come doveva essere la vita dei miei nonni, che invece sento simile alla mia. Anche se ben sapevo che molti palazzi e quartieri a quell’epoca non erano ancora stati costruiti, ‘vederli’ con gli occhi di Zola mi ha colpito. Ammetto che il mio sciovinismo abbia ruggito malinconicamente, ma debbo riconoscere che quanto riferisce Zola (o Zolla con il nome di suo padre italiano) ha molto del vero e (purtroppissimo) ancora oggi Roma abbia troppo da farsi perdonare. In ogni caso la amo, con tutto il cuore, e la trovo struggentemente parte di me.