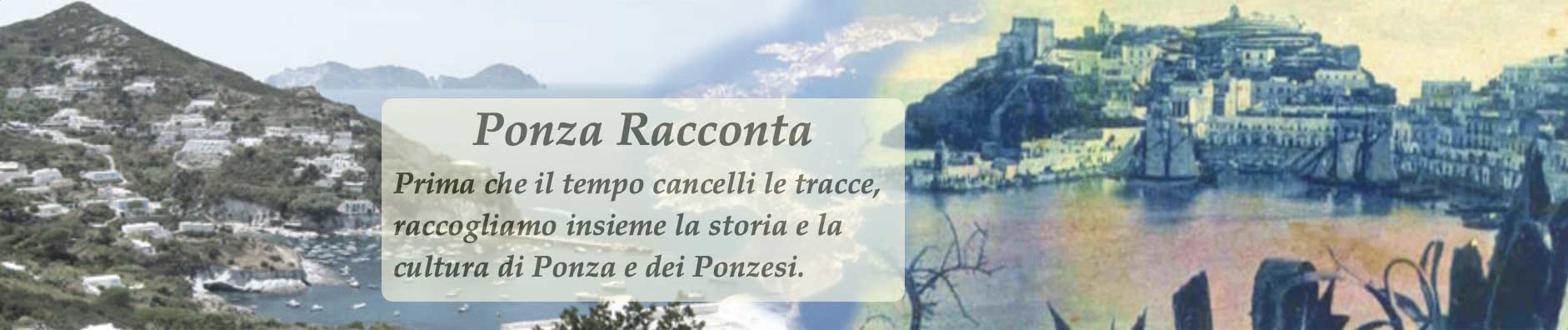di Tonino Impagliazzo
.
Nell’immaginario collettivo, l’espressione arriva ‘u vapore, veniva utilizzata dagli abitanti delle isole per ricordare un evento gioioso e ricco di significati, perché il postale iniettava negli adulti l’antidoto contro la solitudine e l’abbandono e stimolava nei giovani l’idea del nuovo che avanza.
Il “Servizio del Postale”, dalla sua istituzione e fino agli anni ’50 e ’60, si propose agli abitanti delle piccole isole come quel servizio capace di assicurare un collegamento continuativo con la terraferma paragonabile ad un faro di luce nel buio dei servizi minimi essenziali. Ciò voleva dire, tra l’altro, anche l’acquistodi merci e la possibilità di accedere ad un’assistenza specialistica ed ospedaliera qualificata.
La società delegata a tale servizio, per conto dello Stato, era la SPAN di Napoli (nata nel 1912), la quale effettuava in particolare, negli anni ’50 e ’60, due viaggi alla settimana per Napoli ed un viaggio per Gaeta (pontile Elena) poi sostituito dal pontile ex Temperini in Formia.
La SPAN veniva retribuita per il servizio reso ed era disciplinata dai Ministeri competenti, attraverso una specifica Convenzione che prevedeva il numero delle corse, i porti e gli scali di servizio, nonché le caratteristiche tecniche dei battelli destinati al servizio e l’obbligo di esporre nella parte alta del pennone della nave una piccola bandierina triangolare con la scritta “P” (che voleva significare Servizio Postale) .
La Convenzione, meglio descritta come “Servizio sociale minimo a favore delle piccole isole”, proveniva da un’attenta analisi condotta dai funzionari dello Stato, considerando le carenze concrete riscontrate sui territori .
I battelli utilizzati per garantire il servizio delle isole sin dal 1912, portano i nomi M/n “il Lampo”, M/n “Il Frisio” (noleggiato in attesa delle nuove costruzioni), M/n Regina Elena (Ancona 1912), M/n Santa Lucia (Ancona 1912), e dopo la guerra abbiamo M/n Principessa di Piemonte che prenderà poi il nome di M/n Mergellina, M/n il Meta, M/n il Giannutri che hanno lasciato negli abitanti, nelle famiglie, negli studenti e negli addetti ai servizi per l’isola il ricordo dei mitici viaggi, delle traversate avventurose, degli ambienti per il trasporto poco accoglienti e suddivisi per classi sociali, senza dimenticare la durata di sette ore per Napoli e di tre per Gaeta.
Il “Postale” partiva dal Molo Musco di Ponza alle 4,30 del mattino e giungeva all’isola di Ventotene intorno alle 7,30; gettava l’ancora davanti al Porto Romano e/o in zona Parata Grande e calava una scaletta laterale per consentire alla barca a remi proveniente dall’isola di iniziare lo scarico ed il carico delle merci e l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri .
Le operazioni di carico e scarico erano precedute dalla salita sulla Nave del titolare del Servizio postale dell’Isola, cioè ”l’Ufficiale Postale”, il quale si recava dall’Ufficiale di bordo, per la firma di consegna dei plichi (i famosi sacchi di juta sigillati). In questi erano custoditi: i Valori Postali Ordinari (lettere, corrispondenza e stampa varia), i Valori e i Plichi Speciali (raccomandate, assicurate, atti giudiziari, atti speciali ed altro) e anche i Valori e i Plichi Economici Garantiti, visto che in quegli anni gli uffici Postali delle isole di Ventotene e Santo Stefano ungevano anche da Banca e Depositi Fiduciari per rimesse estere e per danaro destinato agli emolumenti dei militari in servizio sulle isole e/o agli addetti ai servici pubblici ed ai carcerati.
Il Postale ripeteva la stessa operazione via mare nelle acque antistantil’isola di Santo Stefano, e capitava sovente di assistere, nella corsa diretta a Napoli, all’imbarco degli ergastolani per udienze di rito, testimonianze od altro, con l’assistenza di due Carabinieri per ogni carcerato.
Nel prosieguo il Postale faceva una breve sosta a Ischia Porto ed a Procida e giungeva a Napoli intorno alle 11,30 del mattino; il giorno successivo ripeteva il viaggio di ritorno per le isole partendo alle 10,00 del mattino.
Nelle isole, il servizio di distribuzione della posta ai cittadini avveniva nel Centro Storico di ciascuna isola: a Ponza sulla piazzetta Pisacane, sotto il Comune; a Ventotene sulla piazzetta posta sui gradini di Casa Balzano ed a Santo Stefano sotto la casa del Direttore sui gradini del Tabacchi. In questi luoghi si radunavano i cittadini che attendevano notizie dai loro cari e i “pacchi dono” provenienti in prevalenza dagli Stati Uniti. La distribuzione si caratterizzava per essere fatta ad alta voce: il postino indicava il nome ed il cognome del destinatario ma quando non vi era alcun riscontro li ripeteva aggiungendovi il soprannome.
Concludo con una considerazione.
I viaggi del Postale, negli anni ’50 e ’60, hanno spalancato agli abitanti di questi territori la strada dell’emancipazione sociale e della crescita culturale e questo, con il sostegno economico integrativo delle famiglie, ha consentito ai ragazzi di proseguire gli studi, lontani dai nuclei familiari con la possibilità di alloggiare presso collegi, case famiglie e/o convitti.
L’esclamazione Arriva ‘u vapore, seppure oggi rimane l’espressione legata ad un viaggio immaginario, di certo non stimola negli isolani, soprattutto nei giovani, né la consapevolezza delle enormi potenzialità di lavoro che questi luoghi possiedono, né una sufficiente analisi delle problematiche sociali, culturali ed economiche legate al periodo invernale. Mancano il desiderio di vivere all’interno della propria realtà insulare e l’impegno per il miglioramento dei servizi di cui c’è bisogno, quasi si temesse di salire la scala della rinascita sociale, culturale ed economica puntando sul senso di appartenenza alla propria terra.