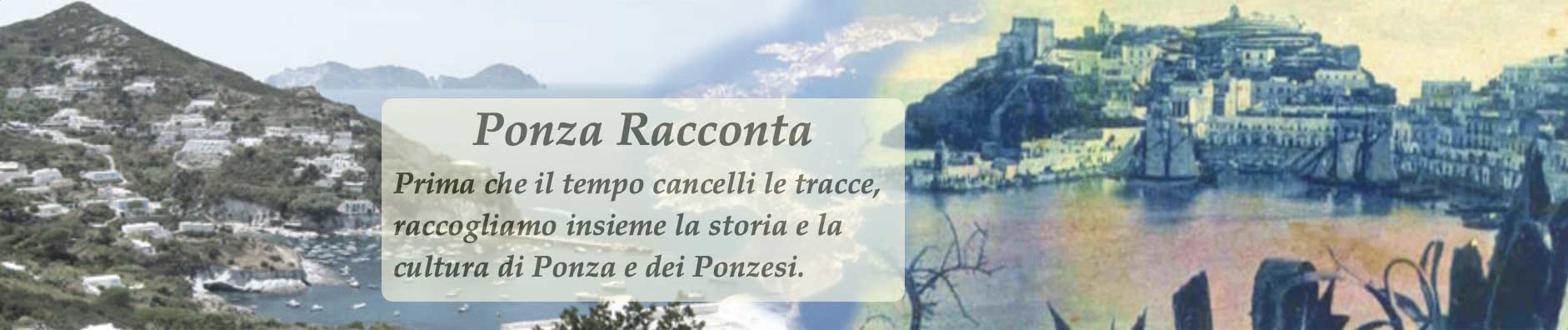.
Tante volte si è detto che quando uno viaggia si porta dietro in valigia tutto il suo mondo. Vede, confronta, desume… e tutto riporta “all’amato scoglio”.
Così è stato un richiamo potente, trovandomi fuori, in Alsazia, la possibilità di visitare l’Ecomusée d’Alsace.
L’Alsazia, una terra martoriata dalla storia, lungamente contesa tra Germania e Francia (di cui testimoniano la cultura e la lingua). A tardivo e parziale risarcimento vanta oggi un Euro Airport (Bale – Mulhouse – Friburg) in condivisione tra la Svizzera (Basilea), la Francia (Mulhouse) e la Germania (Friburgo)
A Ponza (e anche sul sito) è una vita che se ne parla; e mentre da noi se ne parla, altrove – anche vicinissimo a noi, senza andare all’estero – i Musei li fanno davvero, hanno successo e svolgono la loro funzione.
Museo della Migrazione e osservatorio ornitologico di Ventotene
Ne abbiano scritto anche recentemente, per proporre un archivio fotografico come parte del futuro Museo e – Pasquale Scarpati – con la sua idea naïf di museo diffuso, dove in Commento si puntualizzava come l’idea di eco-museo sia di cinquant’anni fa (!), secondo la definizione di Hugues de Varine e Henri Rivière: “Un qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli.”
Che da noi per forza deve essere “diffuso”, perché quello che pomposamente chiamiamo “Museo”, cioè “i Cameroni”, a parte i limiti di spazio, hanno un’acustica indecorosa che li rende alquanto inadatti a qualunque scambio sociale. Non a caso ci fanno i Consigli comunali: perché siano inaudibili!
Ma torniamo in Alsazia, che è meglio!
Una fioritura di Thunbergia alata (Black eyed Susan o Susanna dall’occhio nero) contro il muro di una tipica casa alsaziana
Le origini.
L’idea parte addirittura negli anni ’70 da parte di un gruppo di giovani studenti decisi a salvaguardare delle case rurali alsaziane abbandonate o minacciate di distruzione perché impossibili da recuperare come abitabili secondi criteri ‘moderni’. Ufficializzata nel 1973 con il nome di “Abitazioni contadine alsaziane”, l’associazione restaura numerose case sul posto, dimostrando che un loro recupero è possibile.
Nel 1980 un terreno incolto ad uso industriale dell’estensione di circa 10 ettari è messo a disposizione dell’Associazione dal comune di Ungersheim (nelle vicinanze del più grosso centro della zona: Mulhouse) al fine di rimontarvi delle abitazione rurali che non avevano potuto essere restaurate nei loro villaggi d’origine. Con l’appoggio del Conseil Général du Haut-Rhin, il sito diviene la sede di conservazione delle case tipiche alsaziane e apre al pubblico nel giugno 1981 sotto il nome di “Ecomusée d’Alsace”. Constava all’epoca di 19 fabbricati rimontati e di numerosi altri scrupolosamente conservati, con l’intento di costituire una testimonianza di vita contadina intorno ai primi del ‘900, al trapasso tra la civiltà agricola a quella industriale. C’è anche una vecchia stazione ferroviaria.
Oggi.
Attualmente l’Écomusée d’Alsace forma un villaggio vivo costituito da 74 costruzioni che provengono da tutta l’Alsazia, ricco, oltre che di immobili, di collezioni d’oggetti collegati con le manualità artigianali. Il terreno d’origine, reso sterile dall’estrazione industriale del potassio, trasformato dai fondatori, ospita oggi una natura rigogliosa.
Il visitatore viene dotato, all’ingresso di una semplice mappa del sito che mostra le costruzioni e le attività che vi si svolgono, pur con una certa variabilità legata al ciclo delle stagioni. Ci si muove a piedi, la maggior parte dei visitatori, soffermandosi nei luoghi che più interessano, ma sono previste gite con barchini (silenziosissimi) lungo i canali e con carri da lavoro trainati da cavalli.
Mappa per muoversi agevolmente all’interno del villaggio (cliccare per ingrandire)
L’evoluzione, dalle abitazione tutte in legno a quelle in muratura, è rappresentata dalla tipica casa alsaziana, la cui struttura portante è fatta di grossi travi di legno; tra essi si ordiscono legni più sottili, mentre la tamponatura degli spazi che ne derivano viene fatta con una malta costituita da paglia macerata e argilla, che viene compressa in blocchetti o applicata direttamente alla parete con una precisa tecnica. Queste attività vengono insegnate sul posto ai bambini (visitatori)
Paese prevalentemente agricolo, l’Alsazia, ricco di canali dove si praticava estesamente la pesca. I nidi delle cicogne e il loro significato benaugurante sono comuni a molti paesi dell’Europa dell’Est; particolarmente in Romania
Il futuro
Agli inizi del XXI sec. le finalità dell’Ecomusée d’Alsace si ampliano. Si tratta sempre di conservare, restaurare, spiegare, ma insieme di riflettere sull’habitat del futuro e del “vivere insieme domani” proponendo delle linee-guida.
All’epoca in cui le società occidentali incoraggiano costruzioni rispettose dell’ambiente e dello sviluppo duraturo, l’architettura tradizionale può contribuire a definire un nuovo habitat contemporaneo rispettoso del suo ancoraggio territoriale, rivisitando le sue caratteristica e la sua “arte di vivere? Può contribuire al dialogo sul tema: “come abitare il XXImo secolo”?
In altri termini: si può conservare lo spirito dell’abitazione alsaziana, affrontando con fiducia le sfide del XXI sec.?
Gli ecomusei non sono entità chiuse, non si risolvono in se stessi; essi danno e ricevono. L’Écomusée d’Alsace desidera alimentare il dibattito sul vivere/abitare insieme e servire da terreno di sperimentazione. Sono previste delle istallazioni in cui si proporranno costruzioni contemporanee ispirate al passato, con il contributo di architetti, studiosi, intellettuali, disegnatori, con riferimento a questa affermazione di André Malraux: “Il futuro è un presente che ci rende il passato”.
Maiale nella stalletta annessa ad una tipica casa contadina. Non sembri strana la presenza dei più comuni animali da cortile (anche oche, galline, caprette) se per esempio lo zoo di Roma ha dovuto introdurre una sezione apposita per bambini (di città) che conoscevano i polli solo in versione rosticceria
Incudine e forgia annessi alla bottega del fabbro. Fotografati in onore di Rinaldo Fiore e del suo mitico nonno Carlucce
Birocciaio e fabbro al lavoro. C’era/c’è bisogno di una manualità specifica per costruire le ruote dei carri

Vecchia trebbiatrice, comune anche nelle nostre campagne. Ne ho un ricordo vivido, in quanto in una fase delle sua vita mio padre era in un consorzio di macchine per trebbiare; io quando potevo lo seguivo nelle aie dove si trebbiava il grano. Pericolosissimo (e assolutamente proibito) era avvicinarsi alla lunga cinghia che trasmetteva la forza motrice dal trattore (sempre in moto) ai meccanismi della trebbiatrice
Il vasaio, come pure il vetraio e l’artigiano che legava i vetri a piombo per farne finestre, erano attività artigianali insostituibili in una piccola comunità
Torniamo con il pensiero a Ponza, che è stata sempre ben presente, per cogliere analogie e ispirazione durante la visita.
Salta all’occhio la differenza dei pubblici poteri a promuovere e rendere la strada facile ad un progetto virtuoso che viene dal basso, a fronte della nostra inerzia burocratica; tanto per dire qualcuna delle difficoltà che le diverse amministrazioni hanno dovuto affrontare per (non) realizzare un progetto simile a Ponza.
È evidente che il tema e le finalità di questo ecomuseo d’Alsazia sono diversi dalle nostre; una convergenza si può trovare nella riproposizione di attività manuali e artigianali cadute in disuso; ma manca la necessità – che a Ponza abbiamo – di mostrare nella miglior luce le diverse culture (e i corrispondenti manufatti) che in epoche diverse si sono avvicendate sull’isola.
Interessanti gli aspetti del coinvolgimento dei bambini e l’accento sul futuro, così che la fruizione di un museo sia attiva e interattiva.
Il rischio di una Disneyland culturale è sempre presente, quando si propongono attività e manualità desuete; ma gli aspetti da mostrare sono nella nostra isola così numerosi e densi di significato che credo basti farci la dovuta attenzione.
L’ecomuseo dei fortini borbonici ad Anacapri, aperto nel 2003, è il secondo ecomuseo italiano, e il primo ecomuseo all’aria aperta del mondo